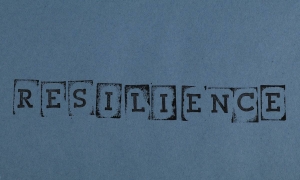PsyMed
Studio Polispecialistico Area Psicologica e Medica a Roma Trastevere
Professionisti al servizio della tua salute!
PsyMed si trova nel cuore di Roma, nel noto e stupendo quartiere storico di Trastevere.
Per prenotare un incontro nello studio di Roma (Trastevere) è necessario compilare le domande che trovi a questo link. Le tue risposte saranno analizzate dai professionisti PsyMed e verrai contattato direttamente dal tuo consulente. Successivamente al primo incontro, verranno decisi i modi, tempi e termini di una eventuale presa in carico della tua richiesta.
Superare eventi traumatici: supporto psicologico in caso di lutti, trasferimenti, malattie gravi ed eventi stressanti
L’impatto degli eventi traumatici sulla vita
Nel corso della vita, quasi tutti affrontiamo eventi traumatici o altamente stressanti: la morte di una persona cara, una diagnosi medica infausta, un trasferimento improvviso o altri cambiamenti radicali possono sconvolgere il nostro equilibrio. In psicologia clinica, un “trauma” non è solo l’evento in sé, ma l’effetto che esso ha sul nostro benessere mentale ed emotivo (American Psychiatric Association, 2013). Possiamo distinguere tra traumi acuti – un singolo episodio di grande impatto come un lutto improvviso o un incidente – e traumi cumulativi, derivanti da stress prolungati o ripetuti nel tempo, come nel caso di malattie croniche, abusi continuativi o perdite multiple ravvicinate. Ognuno di noi reagisce in modo unico a queste esperienze: fattori di vulnerabilità (tra cui esperienze pregresse di trauma, mancanza di supporto sociale, tratti temperamentali) possono aumentare il rischio di sviluppare difficoltà psicologiche persistenti, mentre fattori di resilienza (come un buon sostegno familiare, efficaci strategie di gestione dello stress, flessibilità cognitiva e capacità di dare un significato agli eventi) aiutano molte persone a fronteggiare anche le avversità più dure (Bonanno, 2004). In altre parole, due individui possono vivere lo stesso tipo di evento ma reagire in modo differente: ciò che per uno è un ostacolo insormontabile, per l’altro può diventare un’esperienza di crescita post-traumatica. Un aspetto importante è riconoscere quando le nostre risorse personali non sono sufficienti ad affrontare il peso di quanto accaduto: in questi casi, cercare un supporto psicologico professionale non è segno di debolezza, ma un atto di cura verso se stessi, che può fare la differenza nel percorso di recupero.
Traumi acuti e traumi cumulativi: vulnerabilità e resilienza
I traumi acuti sono eventi singoli e circoscritti nel tempo, come un grave incidente stradale, un’aggressione, un terremoto o la perdita improvvisa di una persona amata. Questi episodi tendono a innescare una reazione istantanea potente: spesso la mente viene travolta da ricordi intrusivi e l’angoscia si manifesta con sintomi fisiologici marcati, come tachicardia, sudorazione, ipervigilanza. Sul piano psicologico, possono emergere incredulità, confusione, sentimenti intensi di paura o di tristezza. Molte persone, nelle prime settimane successive a un trauma acuto, sperimentano una reazione da stress acuto – un mix di shock emotivo e tentativi di adattamento. Fortunatamente, una quota significativa di individui mostra una naturale capacità di recupero: con il passare del tempo e grazie al supporto di familiari e amici, i sintomi si attenuano fino a scomparire o a integrarsi nell’esperienza personale (Bonanno, 2004). Quando però i sintomi persistono a lungo e interferiscono con la vita quotidiana, potremmo trovarci di fronte a un disturbo trauma-correlato (come il Disturbo da Stress Post-Traumatico), che richiede l’intervento di uno specialista.
I traumi cumulativi, al contrario, nascono dall’accumulo di stress ripetuti o prolungati. Pensiamo a chi convive con una malattia grave per anni, a chi assiste un familiare non autosufficiente, oppure a chi subisce piccole ma continue umiliazioni sul lavoro: in questi casi l’impatto traumatico non deriva da un singolo evento esplosivo, ma da una pressione costante goccia dopo goccia. La psicologia riconosce che anche i traumi cumulativi possono essere altamente debilitanti; anzi, talvolta sono subdoli perché la persona può non rendersi conto di “essere al limite” fino a quando il livello di stress sfocia in sintomi importanti (Herman, 1992). Fattori di resilienza come la presenza di rituali quotidiani che danno stabilità, una rete di supporto sociale solida e la capacità di esprimere le proprie emozioni gradualmente possono mitigare gli effetti dello stress cronico. Al contrario, l’isolamento sociale e la mancanza di pause di recupero rendono l’individuo più vulnerabile agli effetti tossici dello stress. Ricerca e clinica sottolineano sempre più l’importanza della coping flexibility, ossia la flessibilità nell’utilizzare diverse strategie di coping a seconda della situazione: una persona in grado di alternare problem solving attivo, ricerca di supporto e tecniche di rilassamento in base alle esigenze del momento è più protetta di chi adotta sempre la stessa risposta allo stress (Cheng et al., 2014). Sia nei traumi acuti che in quelli cumulativi, dunque, esistono dei “fattori protettivi” su cui è possibile lavorare: potenziare le risorse interne ed esterne dell’individuo è uno degli obiettivi fondamentali del supporto psicologico in queste circostanze.
Elaborare il lutto: modelli recenti e possibili complicazioni
Tra gli eventi traumatici più dolorosi e universali vi è la perdita di una persona amata. L’elaborazione del lutto è un processo naturale ma complesso, che la psicologia ha cercato di descrivere con vari modelli teorici. Se in passato si parlava di “fasi del lutto” in modo rigido (negazione, rabbia, patteggiamento, depressione, accettazione secondo il modello di Kübler-Ross degli anni ’60), la visione contemporanea è più sfumata e personalizzata. Un concetto importante emerso negli ultimi decenni è quello del legame continuo (continuing bond): anche dopo la morte, il legame con il defunto può perdurare in forme diverse, e questo non è patologico ma parte integrante del processo di adattamento (Klass et al., 1996). Per esempio, mantenere delle fotografie in casa, parlare mentalmente al proprio caro defunto, o continuare a seguire i suoi valori e insegnamenti sono modi in cui il legame affettivo prosegue e può dare conforto.
Un altro modello influente è il Dual Process Model di Stroebe e Schut (1999), secondo cui chi vive un lutto oscilla tra due modalità: una orientata alla perdita in sé (con tristezza, nostalgia, pensieri rivolti al defunto) e una orientata alla restaurazione (ovvero alla necessità di adattarsi alla nuova vita, svolgere compiti quotidiani, prendere decisioni pratiche dopo la perdita). Questa oscillazione è sana e normale: il lutto non è un percorso lineare in cui “ogni giorno si sta un po’ meglio”, bensì un processo dinamico in cui momenti di relativo benessere possono alternarsi a momenti di intenso dolore, soprattutto in occasione di anniversari, ricorrenze o situazioni che ricordano la persona scomparsa. Un aspetto chiave che aiuta nell’elaborazione è il significato attribuito alla perdita: secondo il modello del meaning making (Neimeyer, 2001), le persone che riescono a dare un senso all’evento luttuoso – ad esempio, trovando un modo per onorare la memoria del defunto o intravedendo una forma di continuità – tendono a mostrare un adattamento migliore. Ciò non significa minimizzare la gravità della perdita, ma integrarla nella propria storia di vita in modo coerente.
Nella maggior parte dei casi, il dolore acuto del lutto si attenua con il tempo e lascia spazio a un ricordo dolceamaro: la persona non dimentica il proprio caro, ma riesce a pensarlo senza essere sopraffatta ogni volta dalle emozioni. Tuttavia, circa il 10-15% delle persone in lutto può sviluppare un lutto complicato persistente (noto anche come disturbo da lutto prolungato), una condizione in cui la sofferenza rimane intensa e debilitante per molti mesi o anni, impedendo alla persona di riprendere le normali attività (Prigerson et al., 2009). Il lutto complesso persistente, formalizzato come diagnosi nel DSM-5-TR e nell’ICD-11, comporta sintomi come un desiderio perenne della persona scomparsa, difficoltà estreme ad accettare la realtà della morte, sentimenti di vuoto e inutilità profondi, e un marcato isolamento sociale (Shear, 2015). In questi casi, l’aiuto professionale diventa fondamentale: approcci psicoterapeutici specifici per il lutto complicato – ad esempio la Complicated Grief Therapy proposta da Shear e colleghi – hanno dimostrato efficacia nel favorire l’elaborazione anche quando il processo si è bloccato (Shear et al., 2016). Riconoscere i segnali di un lutto che non evolve (come l’immutata intensità del dolore a distanza di molto tempo, o la marcata incapacità di funzionare quotidianamente) è importante per individuare quando è opportuno chiedere aiuto e intraprendere un percorso di cura.
Il supporto psicologico per affrontare un lutto
Di fronte a una perdita significativa, molte persone si chiedono cosa fare per “stare meglio” o come aiutare un amico in lutto. In realtà, l’elaborazione del lutto non può essere affrettata o “risolta” con ricette semplici: è un adattamento graduale, che richiede tempo e pazienza. Tuttavia, ci sono interventi di supporto psicologico che possono alleviare la sofferenza e facilitare questo processo naturale. Uno dei primi passi è la psicoeducazione: lo psicologo può spiegare al paziente (o ai familiari) cosa ci si può aspettare dal percorso di lutto, normalizzando le reazioni emotive e fisiche. Sapere, ad esempio, che è comune avere disturbi del sonno, cambiamenti dell’appetito, momenti di “sentirsi insensibili” alternati al pianto disperato, aiuta la persona in lutto a non sentirsi “matta” o sbagliata per ciò che prova. Inoltre, comprendere i modelli teorici (come l’oscillazione del dual process) è rassicurante: chi vive un giorno relativamente buono e poi ricade nel dolore può capire che non sta regredendo, ma sta seguendo un andamento normale.
Un secondo aspetto fondamentale del supporto nel lutto è l’ascolto empatico. Il professionista offre un luogo sicuro in cui esprimere liberamente emozioni anche molto intense – rabbia verso il defunto o verso i medici, senso di colpa per ciò che si è o non si è fatto, paura per il futuro – senza il timore di essere giudicati. Spesso amici e parenti, pur animati da buone intenzioni, non sanno come reagire al dolore altrui e possono cercare di minimizzare (“vedrai che passerà”, “devi essere forte”) o cambiare argomento perché a disagio. Lo psicologo invece sa che dare spazio a queste emozioni è necessario: nominare il dolore, condividerlo, è il primo passo per integrarlo. Attraverso domande sensibili e silenzi accoglienti, lo psicologo aiuta la persona a raccontare la propria storia di perdita, a ricordare il defunto, a esplorare sentimenti ambivalenti che spesso accompagnano il lutto (come amore e risentimento, sollievo e tristezza nel caso di malattie lunghe) e a trovare le proprie strategie di gestione dello stress in questa fase delicata.
Accanto all’ascolto, possono essere impiegate tecniche di ristrutturazione cognitiva per aiutare la persona in lutto a fronteggiare pensieri disfunzionali. Ad esempio, chi rimane bloccato dai sensi di colpa (“avrei dovuto fare di più, è colpa mia se è morto”) può essere guidato a esaminare in modo più obiettivo queste convinzioni: spesso emergono interpretazioni alternative (come riconoscere di aver fatto tutto il possibile nelle circostanze date, o che l’evento era fuori dal proprio controllo) che alleggeriscono il peso dell’auto-colpevolizzazione (Boelen et al., 2006). Anche i pensieri catastrofici sul futuro (“non sarò mai più felice”, “la mia vita è finita”) vengono esplorati e messi in prospettiva, magari attingendo a esperienze passate di resilienza o ai piccoli segnali di ripresa che, col tempo, iniziano a manifestarsi.
Infine, l’utilizzo di rituali simbolici può favorire l’integrazione della perdita. I rituali – che siano tradizionali, spirituali o completamente personali – hanno la funzione di dare uno spazio e un tempo al ricordo e all’espressione emotiva. Lo psicologo può incoraggiare la persona a trovare il rituale più significativo per sé: c’è chi scrive una lunga lettera di addio al defunto per congedarsi, chi pianta un albero in sua memoria, chi ogni anno nel giorno dell’anniversario fa qualcosa che il caro amava fare. Questi gesti simbolici non cancellano il dolore, ma lo rendono più comunicabile e possono creare un ponte tra passato e futuro. In alcuni casi, partecipare a gruppi di sostegno per persone in lutto offre un rituale collettivo di confronto e condivisione: ascoltare storie simili e raccontare la propria in un gruppo mediato da un professionista può far sentire meno soli e fraintesi. In sintesi, superare un lutto non significa dimenticare, ma trovare un modo per convivere con l’assenza mantenendo dentro di sé, in forme nuove, la presenza affettiva di chi non c’è più. Il supporto psicologico aiuta proprio in questo: trasformare la disperazione in ricordo, la rottura in riorganizzazione, rispettando i tempi individuali e la profondità del legame che è stato perduto.
Lo psicologo nelle cure palliative: il sostegno in fine vita
Il supporto psicologico diventa cruciale non solo dopo la perdita, ma anche prima, quando una persona cara sta affrontando una malattia in stadio avanzato e ci si avvicina al fine vita. In ambito di cure palliative lo psicologo svolge un ruolo fondamentale sia per il paziente sia per la famiglia. Da un lato, nel lavoro con il paziente terminale, l’obiettivo è alleviare la sofferenza psicologica e promuovere la migliore qualità di vita possibile nel tempo che rimane. Questo può significare aiutare il malato ad esprimere paure (ad esempio la paura del dolore fisico o dell’ignoto che verrà), elaborare emozioni intense come la rabbia o il senso di ingiustizia, e trovare un significato nell’esperienza che sta vivendo: molti traggono conforto dal riesaminare la propria vita, rievocando ricordi positivi, risolvendo questioni relazionali in sospeso o lasciando un’eredità morale ai propri cari (Chochinov et al., 2005). Tecniche come la “Terapia della Dignità” (basata sul far emergere attraverso interviste strutturate i momenti significativi e i valori della persona, poi restituiti in un documento che rimane al paziente e alla famiglia) hanno dimostrato di ridurre il distress emotivo e aumentare il senso di dignità e significato nei pazienti terminali (Chochinov, 2012). Lo psicologo sostiene anche la comunicazione tra paziente, familiari e équipe curante: facilita discussioni difficili su desideri di fine vita, testamento biologico, o sulla semplice condivisione di paure e sentimenti reciproci, spesso evitati per non ferire l’altro. Una comunicazione aperta e rispettosa può migliorare la vicinanza emotiva in un momento tanto delicato e prevenire rimpianti futuri.
Dall’altro lato, lo psicologo in cure palliative si prende cura dei familiari del paziente, che vivono anch’essi un’esperienza estremamente stressante e dolorosa. I caregiver spesso sperimentano quello che viene definito “lutto anticipatorio”: iniziano a sentire la perdita ancor prima che essa avvenga, oscillando tra speranza e disperazione. Il professionista li aiuta a riconoscere e validare queste emozioni contrastanti, normalizzando il fatto che si possa al contempo desiderare che la sofferenza del proprio caro finisca e sentirsi in colpa per questo pensiero. Inoltre, offre sostegno pratico nell’affrontare l’enorme carico assistenziale: si possono discutere strategie di gestione dello stress quotidiano, consigli per ritagliarsi piccoli spazi di riposo o chiedere aiuto ad altri membri della famiglia o ai servizi territoriali, in modo da prevenire burnout fisico ed emotivo. L’intervento psicologico in questa fase può anche preparare la famiglia al momento della perdita, ad esempio incoraggiando la condivisione di pensieri importanti o l’addio nei modi desiderati, così da ridurre futuri rimpianti. Infine, lo psicologo rimane a disposizione per il follow-up dopo il decesso, offrendo continuità di cura: chi ha accompagnato il malato fino alla fine spesso beneficia di un supporto nel periodo immediatamente successivo, per rielaborare l’esperienza vissuta e avviare in modo sano l’elaborazione del lutto (Hudson et al., 2018). In sintesi, nelle cure palliative la psicologia lavora fianco a fianco con la medicina per affrontare non solo il dolore del corpo, ma anche quello della mente e del cuore, preservando – per quanto possibile – la dignità, i legami affettivi e la qualità della vita fino all’ultimo istante.
Il sostegno psicologico nelle malattie gravi
Anche al di fuori delle situazioni di fine vita, la diagnosi e il decorso di una malattia grave rappresentano eventi potenzialmente traumatici che richiedono un adattamento psicologico significativo. Ricevere una diagnosi di cancro, di sclerosi multipla o di un’altra patologia importante può scatenare una crisi emotiva paragonabile a un lutto: la persona sente che la propria vita “come la conosceva” è finita e deve fare i conti con perdite (di salute, di autonomia, di progetti futuri) e incertezze profonde. Lo psicologo interviene innanzitutto con un assessment del distress: attraverso colloqui e strumenti di screening, valuta il livello di sofferenza psicologica del paziente (ad esempio usando la “distress thermometer” o questionari validati) e individua i principali fattori di difficoltà. Alcuni pazienti possono presentare sintomi d’ansia o gestione dello stress problematiche (come attacchi di panico in ospedale, paura costante della progressione della malattia), altri sviluppano sintomi depressivi (sentimenti di impotenza, perdita di interesse nelle attività, disperazione), altri ancora faticano nelle decisioni terapeutiche, sentendosi sopraffatti dalle informazioni mediche o in conflitto sui trattamenti da seguire. Identificare queste aree consente di personalizzare il supporto psicologico.
Un aspetto cruciale è la promozione dell’adattamento attivo. Lo psicologo aiuta il paziente a mettere in campo risorse e strategie per affrontare la nuova realtà: può significare favorire una migliore comunicazione con i medici (ad esempio preparando insieme una lista di domande da porre durante le visite), insegnare tecniche di rilassamento o mindfulness per ridurre l’ansia durante esami e terapie, e lavorare sulla ridefinizione degli obiettivi di vita a breve e medio termine, in modo da mantenere un senso di progettualità nonostante la malattia (Pesoa et al., 2020). L’intervento psicologico spesso coinvolge anche i familiari del paziente, poiché la malattia grave è un “evento traumatico condiviso” per l’intero sistema familiare: si offrono spazi di ascolto anche ai partner o ai figli, li si aiuta a comprendere le possibili reazioni emotive del malato, e si facilitano dinamiche di supporto reciproco in famiglia.
Oltre al sostegno emotivo, lo psicologo in ambito medico può contribuire al trattamento dei sintomi ansioso-depressivi che talvolta accompagnano le malattie gravi. Ad esempio, può attuare interventi cognitivo-comportamentali brevi per ristrutturare pensieri catastrofici (“questo dolore significa che sto peggiorando”, “la mia vita non ha più valore se non guarisco”) e promuovere comportamenti adattivi (come mantenere, per quanto possibile, le attività quotidiane che danno piacere o senso di normalità). In casi di depressione clinica o ansia marcata, collaborando con medici e psichiatri, si può valutare l’utilizzo di farmacoterapia in parallelo al percorso psicologico, secondo un modello integrato di cura mente-corpo (NCCN, 2021). Lo psicologo offre anche supporto decisionale quando il paziente è chiamato a scelte difficili circa le terapie: ad esempio, decidere se sottoporsi a un intervento rischioso oppure no, o scegliere tra qualità e quantità di vita in fasi avanzate di malattia. In questi frangenti, il terapeuta non dà mai indicazioni sul da farsi, ma aiuta il paziente a esplorare i propri valori, le proprie paure e speranze, facilitando una decisione informata e autenticamente voluta. Studi suggeriscono che il supporto psicologico in oncologia e in altre branche mediche migliora l’aderenza ai trattamenti, riduce i sintomi fisici percepiti (come dolore e fatica) e può persino influire positivamente sui parametri immunitari, dal momento che mente e corpo sono strettamente interconnessi (Spiegel, 1993; Zhou et al., 2019). In definitiva, di fronte a una malattia grave, rivolgersi a uno psicologo non significa affatto “non essere abbastanza forti”, ma anzi è un atto di resilienza: vuol dire utilizzare tutti gli strumenti disponibili – psicologici, medici, sociali – per fronteggiare la sfida e mantenere, per quanto possibile, una buona qualità della vita.
Gestire lo stress nei grandi cambiamenti di vita
Non sono solo lutti o problemi di salute a costituire eventi traumatici o fortemente stressanti. Altri cambiamenti di vita, spesso considerati “normali” o persino positivi, possono rappresentare fonti di stress significativo che mettono alla prova il nostro adattamento. Un trasferimento in un’altra città o paese, ad esempio, comporta la separazione dai propri affetti, dalle abitudini e dai luoghi familiari: anche se avviene per motivi di lavoro o opportunità desiderate, richiede un vero e proprio processo di adattamento culturale ed emotivo. Similmente, un cambiamento di lavoro, il pensionamento, la nascita di un figlio o la fine di una relazione importante sono transizioni che implicano una riorganizzazione profonda della vita quotidiana e dell’identità personale. La psicologia dello stress ci insegna che ciò che determina l’impatto di un evento non è solo la sua natura oggettiva, ma il significato soggettivo che la persona gli attribuisce e le risorse di cui dispone per farvi fronte (Lazarus & Folkman, 1984). Così, un trasferimento può essere vissuto come un’eccitante avventura o come una perdita lacerante, a seconda del contesto e del vissuto individuale.
Nell’ambito del supporto psicologico ai grandi cambiamenti, un concetto utile è quello di coping-flexibility: la capacità di adattare le proprie strategie di coping alle richieste specifiche della situazione (Cheng et al., 2014). Ad esempio, di fronte a un cambio di lavoro stressante, potrebbe essere necessario combinare strategie di gestione dello stress di tipo orientato al problema (come organizzare un piano per apprendere nuove competenze richieste dal ruolo, chiedere chiarimenti ai superiori, stabilire una routine per gestire il tempo) e strategie orientate all’emozione (come praticare tecniche di rilassamento per tenere a bada l’ansia, coltivare hobby piacevoli per ricaricare le energie, parlare delle proprie preoccupazioni con persone fidate). Lo psicologo può insegnare queste abilità in un contesto di consulenza breve focalizzata sul problema: ad esempio, attraverso il problem solving counseling si guida la persona a definire chiaramente la difficoltà, a generare possibili soluzioni, valutarne pro e contro, e pianificare passi concreti da attuare (Nezu et al., 2013). Contemporaneamente, si lavora sulla regolazione emotiva: ciò può includere tecniche cognitivo-comportamentali per ridimensionare pensieri catastrofici (“e se non ce la faccio nel nuovo posto di lavoro?”) e sostituirli con valutazioni più equilibrate (“ci vorrà un periodo di adattamento, ma ho superato sfide simili in passato”), oppure pratiche di mindfulness per riprendere contatto col momento presente quando la mente vaga tra rimpianti del passato e timori del futuro.
Un altro ingrediente importante è il mantenimento o la costruzione di una rete di supporto nel nuovo contesto di vita. Affrontare un trasferimento o un cambio radicale può far sentire soli; per questo, lo psicologo incoraggia la persona a identificare fonti di supporto – che siano colleghi, gruppi di interesse, vicini di casa o parenti lontani da sentire regolarmente via telefono – e a investire nella creazione di nuovi legami. Anche il celebrare simbolicamente il passaggio può aiutare: ad esempio, organizzare un saluto con i vecchi amici prima di trasferirsi, o stabilire dei rituali nella nuova casa che diano un senso di continuità e identità (appendere foto care, ritagliarsi un “angolo personale” familiare nell’ambiente estraneo). Questi accorgimenti, uniti alle strategie di coping apprese, facilitano l’adattamento e riducono il rischio che lo stress acuto del cambiamento evolva in un malessere più profondo come un disturbo d’ansia o depressivo. Naturalmente, se nonostante gli sforzi la persona si sente sopraffatta – per esempio, compaiono attacchi di panico dopo il trasloco, o un persistente umore depresso che non accenna a migliorare – è importante considerare l’opportunità di un aiuto professionale. A volte pochi colloqui di sostegno psicologico durante una transizione bastano a riorientare la situazione, prevenendo complicazioni maggiori e fornendo strumenti che rimarranno utili per la vita.
Quando chiedere aiuto: segnali e tempestività dell’intervento
Comprendere quando e perché chiedere aiuto a un professionista è fondamentale per prevenire che gli effetti di eventi traumatici o stressanti si cronicizzino. Ma quali sono i segnali d’allarme da non ignorare? Un indicatore chiave è il compromesso del funzionamento quotidiano: se a distanza di settimane o mesi dall’evento la persona fa fatica a svolgere le sue normali attività (andare al lavoro o a scuola, curare l’igiene personale, gestire la casa), questo indica che l’impatto psicologico è stato tale da bloccare le sue usuali capacità. Ad esempio, dopo un lutto può essere normale prendersi un periodo di pausa, ma se dopo sei mesi non si riesce ancora ad alzarsi dal letto la maggior parte dei giorni, o non ci si sente in grado di uscire di casa, è probabile che si sia instaurato un quadro depressivo o ansiogeno che necessita di attenzione clinica. Un altro segnale è l’isolamento sociale marcato: evitare costantemente il contatto con gli altri, ritirarsi da ogni interazione, può significare che il livello di sofferenza o vergogna (in caso di trauma che implica stigma) è molto alto. L’evitamento persistente di luoghi o situazioni collegati al trauma (non entrare più in auto dopo un incidente, rifiutarsi di andare in ospedale dopo una degenza traumatica) è uno dei sintomi tipici del Disturbo Post-Traumatico da Stress e, se limita significativamente la vita della persona, richiede un intervento mirato (APA, 2013).
Altri campanelli d’allarme sono le manifestazioni emotive e cognitive estreme. L’ideazione suicidaria, ad esempio, è sempre da prendere sul serio: se una persona comincia a pensare che “non vale più la pena di vivere” o ha fantasie di farsi del male per sfuggire al dolore, è necessario cercare aiuto immediatamente, rivolgendosi a uno psicologo o psichiatra o contattando i servizi di emergenza. Anche senza arrivare a questi estremi, la presenza di attacchi di panico frequenti, crisi di pianto inconsolabili quotidiane, rabbia esplosiva incontrollabile o al contrario un’apatia profonda e persistente sono segnali che la mente sta lanciando un SOS. A volte è la durata nel tempo a fare la differenza: brevi periodi di insonnia, incubi o irritabilità dopo un evento stressante rientrano nel normale decorso, ma se dopo mesi questi sintomi continuano imperterriti – o peggiorano – probabilmente il naturale processo di recupero si è inceppato.
Chiedere aiuto professionale in modo tempestivo può prevenire complicazioni e favorire una ripresa più rapida. Purtroppo, molti esitano per vergogna o perché pensano di dovercela fare da soli. In realtà, riconoscere di avere bisogno di sostegno è un atto di coraggio e lucidità. Uno psicologo o psicoterapeuta può offrire una valutazione accurata della situazione e capire insieme alla persona se è indicato intraprendere un percorso di terapia, se può essere sufficiente un breve consulto o se è il caso di coinvolgere anche un medico (ad esempio per una valutazione psichiatrica nel caso vi sia il sospetto di un disturbo maggiore). Le linee guida internazionali (ad esempio dell’American Psychological Association e del National Institute for Health and Care Excellence) convergono nel raccomandare interventi precoci per i disturbi legati a eventi traumatici e da stress, sottolineando che prima si interviene, più è facile evitare che il malessere si cronicizzi o si estenda ad altre aree della vita (NICE, 2018). In sintesi, è bene chiedere aiuto quando il dolore psichico diventa troppo intenso, prolungato o invalidante. Non c’è un “numero di giorni” preciso oltre il quale bisognerebbe guarire – ognuno ha i suoi tempi – ma se la persona sente di essere bloccata, di non riuscire più a gestire le emozioni o i compiti quotidiani, quella è la voce interiore che suggerisce di tendere la mano verso chi è in grado di offrire strumenti di supporto. Lo psicologo non ha soluzioni magiche, ma ha competenze per fare da guida attraverso il buio, modulando gli interventi sul singolo caso e collaborando, se necessario, con psichiatri, medici di base o altri professionisti in un approccio davvero multidisciplinare al benessere.
Terapie efficaci per trauma e stress: CBT, EMDR, Narrazione, ACT
Una volta presa la decisione di rivolgersi a un professionista per superare eventi traumatici o periodi di stress intenso, è naturale chiedersi quale tipo di terapia potrebbe essere più indicato. Negli ultimi decenni, la ricerca in psicoterapia ha identificato diversi approcci terapeutici efficaci nel trattamento del trauma e dei disturbi da stress, ognuno con specifiche tecniche e indicazioni. La Terapia Cognitivo-Comportamentale focalizzata sul trauma (TF-CBT) è uno degli interventi con maggiore evidenza scientifica per il Disturbo da Stress Post-Traumatico e problematiche affini (Bisson et al., 2013). Questo approccio include tecniche come l’esposizione immaginativa o in vivo (rivivere gradualmente e in sicurezza i ricordi traumatici o le situazioni evitate per desensibilizzarsi alla paura), la ristrutturazione cognitiva dei pensieri negativi legati all’evento (“È stata colpa mia”, “Non sono al sicuro da nessuna parte”) e l’insegnamento di abilità di gestione dell’ansia (rilassamento, respirazione controllata). Una forma specifica di terapia cognitivo-comportamentale per il trauma è la Cognitive Processing Therapy (CPT), che aiuta in particolare a elaborare i significati del trauma e le credenze di base che ne sono scaturite (Resick et al., 2017). Un’altra è la Prolonged Exposure, in cui l’esposizione prolungata ai ricordi traumatici consente un abituarsi graduale e una rielaborazione emotiva dell’evento (Foa et al., 2019). Le terapie CBT focalizzate sul trauma tendono ad essere strutturate e di durata limitata (8-16 sedute circa), e la loro efficacia è supportata da linee guida internazionali, che le considerano trattamenti di prima linea per il PTSD (APA, 2017; NICE, 2018).
Accanto alla CBT, un approccio oggi ampiamente riconosciuto è l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). L’EMDR si basa sul concetto che i ricordi traumatici non adeguatamente “digeriti” rimangono come intrappolati nel sistema nervoso, continuando a innescare disagio. Durante le sedute di EMDR, il terapeuta guida il paziente a rievocare gli aspetti più disturbanti dell’evento mentre esegue contemporaneamente dei movimenti oculari guidati (o altre forme di stimolazione bilaterale alternata, come suoni o tocchi ritmici). Questo processo, scoperto da Francine Shapiro, facilita una rielaborazione accelerata dei ricordi traumatici, riducendone la carica emotiva e i sintomi associati (Shapiro, 2018). Numerosi studi controllati hanno confermato l’efficacia dell’EMDR nel ridurre i sintomi post-traumatici, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità e diverse linee guida nazionali lo raccomandano come trattamento evidence-based per il PTSD (WHO, 2013). L’EMDR, pur essendo strutturato, tende ad essere percepito dai pazienti come meno gravoso dell’esposizione pura, perché l’attenzione è divisa tra il ricordo e lo stimolo bilaterale, rendendo l’esperienza più tollerabile; per questo viene spesso scelto da chi fatica ad affrontare direttamente il ricordo traumatico.
Un altro filone terapeutico utile in caso di traumi e perdite è la Terapia Narrativa. Questo approccio parte dall’idea che noi diamo senso alla nostra vita attraverso storie: un evento traumatico può frammentare la narrativa personale, lasciando la persona con un “buco” o una storia di vita dominata dal trauma. La terapia narrativa, sviluppata da White ed Epston (1990), aiuta il paziente a *ri-narrare* la propria storia in modo più articolato e coerente, separando la persona dal problema (esternalizzazione) e valorizzando le competenze e i significati personali emersi nonostante (o a seguito di) l’evento difficile. Ad esempio, con una persona che ha subito un trauma si può lavorare per costruire il “capitolo” di quell’evento all’interno dell’autobiografia: collocarlo nel tempo, ricordare non solo il dolore ma anche le risorse attivate per superarlo, e integrare il trauma come una parte della vita ma non l’unica definente. Tecniche narrative vengono impiegate anche con chi vive un lutto: scrivere una lettera di commiato, creare un album dei ricordi commentato, o persino immaginare un dialogo con la persona perduta, sono modalità narrative di elaborazione. Un formato strutturato è la Narrative Exposure Therapy (Schauer et al., 2011) utilizzata con sopravvissuti a traumi multipli (come rifugiati di guerra): in questo metodo, il paziente con l’aiuto del terapeuta costruisce cronologicamente la “linea del tempo” della propria vita, intrecciando i fatti traumatici con quelli positivi, in modo che la memoria integri ogni capitolo in un racconto unitario. La narrazione ha un potere catartico e organizzativo: dare parole al vissuto aiuta a rimettere ordine nel caos interno e a vedere la propria esperienza da una prospettiva più ampia, spesso accendendo una luce di significato e continuazione dove prima c’era solo buio.
Infine, tra gli approcci moderni merita spazio l’Acceptance and Commitment Therapy (ACT), appartenente alle terapie di “terza onda” cognitivo-comportamentali. L’ACT non mira a eliminare a tutti i costi il dolore o i ricordi traumatici, bensì ad aiutare la persona a cambiarvi relazione: insegna ad accettare la presenza di pensieri ed emozioni difficili come parte dell’esperienza umana, riducendone l’impatto attraverso pratiche di mindfulness e defusione cognitiva (cioè guardare i pensieri per quello che sono – eventi mentali – senza lasciarsi dominare da essi) (Hayes et al., 2016). Allo stesso tempo, l’ACT spinge a identificare ciò che per la persona è davvero importante (i propri valori di vita) e a impegnarsi in azioni concrete guidate da questi valori, anche in presenza di qualche sintomo. Applicata ai traumi e ai lutti, l’ACT si è dimostrata efficace nell’alleviare il distress e promuovere la crescita post-traumatica (Twohig & Levin, 2017). Ad esempio, una madre che ha perso un figlio potrebbe non riuscire a cancellare il dolore (né sarebbe realistico aspettarselo), ma attraverso il percorso ACT potrebbe imparare a permettere a quella sofferenza di esistere senza esserne distrutta, e magari scegliere di impegnarsi in azioni in linea con l’amore per il figlio – come partecipare ad attività di volontariato in sua memoria – trovandovi un nuovo scopo. In generale, la scelta dell’approccio terapeutico più adatto dipende da vari fattori: il tipo di evento vissuto, la diagnosi specifica (se presente), le preferenze e la personalità del paziente, oltre che la formazione del terapeuta. Spesso elementi di diverse terapie vengono integrati in modo sartoriale in un percorso cucito sulle esigenze individuali. Ciò che conta, come indicano le ricerche sull’efficacia della psicoterapia, è la qualità della relazione terapeutica e l’adattamento degli interventi alla persona: un terapeuta esperto valuterà con il paziente il percorso migliore, monitorando i progressi e apportando aggiustamenti in un processo collaborativo e trasparente (Norcross & Wampold, 2019).
Rete di supporto e pratiche di autocura nella ripresa
Oltre ai percorsi clinici strutturati, un ruolo fondamentale nel superare eventi traumatici è giocato dalle risorse quotidiane che circondano e appartengono all’individuo. La rete di supporto sociale – famiglia, amici, gruppi comunitari – costituisce spesso un argine potente contro lo sviluppo di problemi psicologici dopo un trauma. Sapere di poter contare su qualcuno, sentire che nonostante tutto non si è soli, offre sicurezza emotiva e pratica: un amico che ascolta senza giudizio, un parente che aiuta nelle incombenze quotidiane quando noi non ne abbiamo la forza, un collega che mostra comprensione possono fare la differenza nei giorni più bui (Ozbay et al., 2007). La psicologia sottolinea anche l’importanza di chiedere e accettare aiuto: non di rado chi soffre tende a isolarsi per non “disturbare” gli altri, oppure perché si vergogna della propria fragilità. Imparare invece a esprimere i propri bisogni – che sia la necessità di compagnia, di parlare o anche solo di una pausa dalle responsabilità quotidiane – permette al supporto sociale di attivarsi in modo efficace. Esistono inoltre risorse comunitarie che vale la pena considerare: i gruppi di mutuo-aiuto tra persone che hanno vissuto esperienze simili (ad esempio gruppi per vedovi/e, per pazienti oncologici, per vittime di atti criminali), le associazioni di volontariato (che offrono servizi di sostegno pratico o psicologico a domicilio), fino ai servizi di assistenza spirituale o religiosa per chi trova conforto nella dimensione della fede. Attivare la comunità attorno all’individuo significa tessere una rete di sicurezza più ampia, in cui ognuno – dallo psicologo al vicino di casa – può avere un ruolo nel processo di guarigione emotiva.
Parallelamente al supporto esterno, non va dimenticato il potere delle pratiche di autocura nel favorire il recupero. Corpo e mente sono interconnessi: prendersi cura delle proprie esigenze fisiche aiuta enormemente anche l’equilibrio psicologico. Dopo un evento traumatico o in una fase di stress intenso, può sembrare banale, ma garantire a se stessi un buon ritmo sonno-veglia, un’alimentazione bilanciata e un po’ di attività fisica regolare è già parte del processo di guarigione. Il sonno in particolare svolge un ruolo chiave nella consolidazione della memoria e nella regolazione delle emozioni: dormire poco o male amplifica l’irritabilità, la tristezza e l’ansia, mentre un sonno sufficiente e di qualità migliora la resilienza psicologica (Harvey et al., 2011). Anche l’alimentazione incide sull’umore: carenze di certi nutrienti (come vitamine del gruppo B, Omega-3, magnesio) possono accentuare sintomi depressivi o ansiosi, quindi nutrirsi in modo vario e completo sostiene letteralmente il cervello nel suo lavoro di adattamento. L’esercizio fisico, dal canto suo, è un anti-stress naturale: attività aerobiche moderate, come camminare a passo sostenuto, nuotare o andare in bici, stimolano il rilascio di endorfine e altri neurotrasmettitori benefici, riducendo la tensione e migliorando il tono dell’umore (Salmon, 2001). Persino una semplice passeggiata quotidiana all’aria aperta può avere effetti positivi tangibili sul benessere mentale, specie se svolta in mezzo al verde.
Tra le pratiche di autocura rientrano anche le tecniche di mindfulness e meditazione, che stanno ricevendo crescente attenzione scientifica per i loro benefici sulla regolazione emotiva. Dedicare ogni giorno qualche minuto alla respirazione consapevole, alla meditazione guidata o a esercizi di mindfulness (come il body scan o l’osservazione non giudicante dei propri pensieri) può ridurre i livelli di stress percepito e aumentare la capacità di stare nel presente senza essere travolti dai ricordi dolorosi o dalle preoccupazioni (Hölzel et al., 2011). Allo stesso modo, attività creative o espressive – disegno, scrittura di un diario, musica – hanno un effetto terapeutico, offrendo modi alternativi di elaborare le emozioni quando le parole non bastano. È importante sottolineare che queste strategie di autocura non sostituiscono l’intervento professionale nei casi in cui esso sia necessario, ma lo integrano e potenziano. Un percorso psicologico efficace incoraggerà sempre la persona a coltivare le proprie risorse fisiche, creative, relazionali: la terapia non avviene solo nell’ora di seduta, ma anche nelle restanti ventitré in cui l’individuo applica, nella vita reale, ciò che sta imparando. In definitiva, la ripresa dopo un trauma o uno stress intenso è il risultato di una combinazione di fattori: il lavoro interiore guidato dalla terapia, il sostegno caldo degli affetti e della comunità, e le cure quotidiane che la persona riserva a se stessa. Nessuno di questi elementi, da solo, è “la bacchetta magica”; ma insieme possono creare un terreno fertile perché la ferita pian piano si rimargini.
Supporto psicologico in caso di lutti, trasferimenti, malattie gravi ed eventi stressanti
Superare eventi traumatici non significa dimenticare ciò che è accaduto o fare finta che il dolore non ci sia stato. Al contrario, significa integrare l’esperienza – per quanto dura – nella propria storia di vita, ritrovare un senso di continuità e aprirsi alla possibilità di un futuro ancora ricco di significati. Abbiamo visto come il supporto psicologico possa offrire strumenti preziosi in questo percorso: dalla comprensione dei meccanismi del trauma e del lutto (capendo cosa è “normale” provare e quali segnali indicano invece un blocco patologico), fino alle tecniche pratiche per la gestione dello stress e la rielaborazione dei ricordi dolorosi, la psicologia fornisce un aiuto concreto e basato sull’evidenza scientifica. Modelli recenti ci hanno insegnato ad avere una visione più umana e personalizzata della sofferenza: sappiamo che ognuno ha tempi e modi propri per elaborare un lutto, che il legame con chi abbiamo perso può persistere in forme nuove (e ciò va bene così), che non esiste una “reazione giusta” ai eventi traumatici ma esistono tante storie di resilienza quante sono le persone. Allo stesso modo, la clinica ci mostra che chiedere aiuto al momento opportuno può prevenire esiti più gravi: intervenire precocemente, sia con un sostegno psicologico breve per gestire uno stress situazionale, sia con una psicoterapia strutturata in caso di disturbi conclamati, aumenta le probabilità di ristabilirsi più in fretta e completamente.
Un messaggio fondamentale è l’importanza di un approccio integrato e personalizzato. Non c’è una soluzione unica valida per tutti: alcune persone trarranno giovamento da una Terapia Cognitivo-Comportamentale focalizzata sul trauma, altre da un percorso di EMDR, altre ancora da un lavoro espressivo o dalla partecipazione a gruppi di supporto – spesso, la combinazione di più interventi è ciò che porta ai migliori risultati. La personalizzazione significa considerare la persona nella sua totalità: gli aspetti psicologici, certo, ma anche quelli fisici, sociali e spirituali. Per questo, la collaborazione multidisciplinare tra psicologi, medici, psichiatri, assistenti sociali e caregiver è spesso la chiave di volta di un sostegno efficace. Ad esempio, nel caso di una malattia grave, il confronto costante tra lo psicologo, l’oncologo o il neurologo curante e magari l’infermiere di riferimento assicura che tutti gli aspetti della cura vadano nella stessa direzione, mettendo al centro la qualità di vita del paziente e dei familiari. Nei percorsi di elaborazione del lutto, il coinvolgimento del medico di base o del sacerdote/celebrante (se la dimensione spirituale è rilevante per la persona) può arricchire l’intervento psicologico, creando una rete di cura attorno al paziente. L’obiettivo ultimo è che la persona non si senta mai abbandonata ad affrontare da sola l’onda d’urto del trauma: l’aiuto è disponibile e può assumere tante forme complementari.
In conclusione, affrontare e superare eventi traumatici è un viaggio faticoso, ma non bisogna dimenticare che molte persone, con il giusto aiuto, riescono non solo a guarire le proprie ferite ma anche a scoprire in sé risorse inaspettate. La sofferenza, se elaborata, può trasformarsi in una maggiore consapevolezza di sé, in empatia verso gli altri, in nuove priorità di vita. Ogni percorso è diverso, ma nessuno deve intraprenderlo in solitudine: il supporto psicologico, unito al calore delle relazioni e alle buone pratiche di autocura, rappresenta un ponte verso la ripresa. Chiedere aiuto quando serve significa concedersi l’opportunità di stare meglio e onorare la propria capacità di adattamento e crescita. Presso centri specializzati come Psymed, diverse figure professionali – psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, nutrizionisti e altri – lavorano insieme secondo il modello bio-psico-sociale per offrire alla persona un sostegno completo, perché il benessere psicologico è un diritto e una componente essenziale della salute globale. Ricordiamo dunque che, per quanto buia possa sembrare la notte dopo un trauma, vi sono strumenti e persone pronti ad accendere una luce: non esitare a tendere la mano, perché la strada della guarigione esiste e può essere percorsa, un passo alla volta, insieme.
Fonti: American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience. American Psychologist, 59(1), 20-28. Herman, J. (1992). Trauma and Recovery. Klass, D., Silverman, P. R., & Nickman, S. (1996). Continuing Bonds: New Understandings of Grief. Stroebe, M., & Schut, H. (1999). The dual process model of coping with bereavement. Death Studies, 23(3), 197-224. Prigerson, H. G., & altri (2009). Prolonged Grief Disorder: Psychometric validation of criteria. PLoS Medicine, 6(8), e1000121. Shear, M. K. (2015). Complicated grief. New England Journal of Medicine, 372(2), 153-160. Chochinov, H. M., & altri (2005). Dignity therapy: a novel therapeutic intervention in palliative care. Journal of Clinical Oncology, 23(24), 5520-5525. Chochinov, H. M. (2012). Dignity Therapy: Final words for final days. Hudson, P., & altri (2018). The contribution of psychosocial care to palliative care. Medical Journal of Australia, 208(5), 203-205. Pesoa, A. C., & altri (2020). Psychological adaptation to illness. Frontiers in Psychology, 11, 588736. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Cheng, C., & altri (2014). Coping flexibility and psychological adjustment to stressful life changes. Frontiers in Psychology, 5, 809. Nezu, A. M., & altri (2013). Problem-Solving Therapy (2nd ed.). NICE (2018). Guideline NG116: Post-traumatic stress disorder. Bisson, J. I., & altri (2013). Psychological therapies for chronic PTSD (Review). Cochrane Database Syst Rev, 12, CD003388. Resick, P. A., & altri (2017). Cognitive Processing Therapy for PTSD. Foa, E. B., & altri (2019). Prolonged Exposure Therapy for PTSD (2nd ed.). Shapiro, F. (2018). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapy (3rd ed.). WHO (2013). Guidelines for the management of conditions specifically related to stress. White, M., & Epston, D. (1990). Narrative Means to Therapeutic Ends. Schauer, M., Neuner, F., & Elbert, T. (2011). Narrative Exposure Therapy (2nd ed.). Hayes, S. C., & altri (2016). Acceptance and Commitment Therapy: Processes and outcomes. Current Opinion in Psychology, 2, 99-107. Twohig, M. P., & Levin, M. E. (2017). Acceptance and commitment therapy as a treatment for anxiety and depression. APA Handbook of Behavior Analysis (Vol. 2). Ozbay, F., & altri (2007). Social support and resilience to stress: from neurobiology to clinical practice. Psychiatry, 4(5), 35-40. Harvey, A. G., & altri (2011). Sleep and circadian functioning in PTSD. Sleep Medicine Reviews, 15(1), 15-22. Salmon, P. (2001). Effects of physical exercise on anxiety, depression, and sensitivity to stress. Clinical Psychology Review, 21(1), 33-61. Norcross, J. C., & Wampold, B. E. (2019). Evidence-based therapy relationships: Research conclusions and clinical practices. Psychotherapy, 56(4), 423-433.
Affrontare l’Ansia: Strumenti di Autoregolazione e Tecniche Psicologiche
Psicologia applicata per riconoscere e gestire ansia, attacchi di panico e fobie
L’ansia è un’emozione umana universale, parte integrante del nostro repertorio di reazioni allo stress e ai pericoli. In una certa misura, provare ansia è fisiologico e può persino essere utile: un livello moderato di attivazione può migliorarci l’attenzione prima di un esame o renderci più pronti ad affrontare situazioni sfidanti. L’ansia normale, infatti, è la naturale risposta di allarme del corpo, collegata al meccanismo “lotta o fuga” che ci preparava, fin dai tempi ancestrali, a reagire a possibili minacce. Tuttavia, quando questa risposta diventa eccessiva, ingiustificata o cronica, può trasformarsi in ansia patologica, causando sofferenza significativa e interferendo con la vita quotidiana (American Psychiatric Association, 2013). È qui che intervengono la psicologia applicata e le tecniche psicologiche mirate: attraverso strumenti di autoregolazione emotiva e interventi terapeutici basati sull’evidenza, è possibile riconoscere e gestire efficacemente l’ansia, gli attacchi di panico e le fobie, aiutando la persona a ritrovare equilibrio e benessere.
Ma che cosa intendiamo esattamente per ansia clinica?
In ambito contemporaneo si distingue tra l’ansia “normale” – una reazione passeggera proporzionata allo stimolo stressante – e l’ansia “patologica” – persistente, intensa, sproporzionata o priva di un vero pericolo esterno (Clark & Beck, 2020). Quest’ultima si manifesta nei disturbi d’ansia, una categoria eterogenea di condizioni psicologiche descritte nei manuali diagnostici internazionali (APA, 2013). Fra i principali vi sono il Disturbo d’Ansia Generalizzato (GAD), caratterizzato da una preoccupazione cronica e incontrollabile per molteplici aspetti della vita quotidiana; il Disturbo di Panico, in cui la persona sperimenta ricorrenti attacchi di panico improvvisi e intensi, spesso accompagnati dal timore di morire o impazzire; le fobie specifiche, ovvero paure marcate e persistenti verso oggetti o situazioni circoscritte (come volare, alcuni animali, l’altezza) che portano ad evitare attivamente lo stimolo fobico; e il Disturbo d’Ansia Sociale (o fobia sociale), in cui prevale il terrore di esporsi al giudizio altrui in contesti sociali o di performance. Pur con le loro peculiarità, questi disturbi condividono il nucleo di un’ansia eccessiva che sfugge alla volontà della persona, differenziandosi dalla normale paura per il grado di sofferenza e disfunzione che comportano.
Riconoscere i segnali dell’ansia è un passo fondamentale per poterne riprendere il controllo. Dal punto di vista somatico, l’ansia attiva il sistema nervoso simpatico dando luogo a sintomi fisici spesso molto intensi: il cuore batte più in fretta, la respirazione diventa rapida o superficiale, i muscoli si tendono, si può avvertire sudorazione, tremori, vertigini, un nodo allo stomaco o nausea. Queste sensazioni corporali – un tempo utili per prepararci a scappare dai pericoli – oggi possono apparire improvvise e inappropriate, come nel caso di un attacco di panico in un luogo affollato o prima di parlare in pubblico. Sul piano cognitivo, l’ansia è alimentata da pensieri caratteristici: previsioni catastrofiche (“andrà tutto male”), preoccupazioni continue e invasive, difficoltà a concentrarsi su altro che non sia la fonte di minaccia percepita, e un bias attentivo che ci fa notare maggiormente i possibili segnali di pericolo. Dal punto di vista emotivo, l’ansia può manifestarsi come paura diffusa, irritabilità, nervosismo, fino a un senso di terrore paralizzante negli episodi più acuti. A livello comportamentale, spesso si instaurano pattern di evitamento: la persona comincia a evitare le situazioni che teme possano innescare l’ansia (ad esempio smette di guidare dopo un attacco di panico in auto, oppure rifiuta inviti sociali per paura di imbarazzarsi), oppure mette in atto “comportamenti di sicurezza”, strategie apparentemente rassicuranti ma disfunzionali (come portare sempre con sé un ansiolitico, una bottiglietta d’acqua o chiamare continuamente un familiare per sentirsì al sicuro). Questi evitamenti e rituali, pur riducendo l’ansia nell’immediato, in realtà la rinforzano nel lungo termine, perché impediscono alla persona di confrontarsi con le sue paure e di sperimentare che può tollerare l’ansia senza che accada nulla di catastrofico.
Un altro aspetto cruciale è l’impatto dell’ansia sul funzionamento quotidiano.
Segnali precoci di un problema d’ansia includono difficoltà a dormire a causa dei pensieri preoccupanti, affaticamento costante dovuto alla tensione, irritabilità o difficoltà a prendere decisioni per paura di sbagliare. Col tempo, l’ansia patologica può compromettere lo studio, il lavoro e le relazioni: basti pensare a chi, per via dell’ansia sociale, rinuncia a opportunità professionali che comportino parlare in pubblico, o a chi con disturbo di panico limita progressivamente il perimetro delle proprie attività – smettendo di viaggiare, usare i mezzi pubblici o restare solo – sviluppando in casi estremi una vera e propria agorafobia. Riconoscere questi pattern e segnali permette di intervenire prima che l’ansia restringa sempre di più la vita della persona. In questo senso, la psicoeducazione – ovvero comprendere cosa sia l’ansia, quali meccanismi fisiologici e psicologici la alimentano, e come si possa spezzare il circolo vizioso – è già di per sé uno strumento d’aiuto potente: sapere che i sintomi fisici che proviamo (come tachicardia o capogiri) sono la normale attivazione adrenergica dello stress e non segnali di un infarto o di “impazzire” riduce l’allarme secondario e la paura della paura (Bourne, 2020).
Una volta identificata l’ansia e le sue manifestazioni, il passo successivo è adottare rimedi per calmare l’ansia e riconquistare una sensazione di padronanza. Tra le tecniche di autoregolazione emotiva più efficaci vi è la respirazione diaframmatica: si tratta di una modalità di respirazione lenta e profonda, che coinvolge il diaframma (la “respirazione di pancia”), capace di attivare il sistema nervoso parasimpatico e contrastare la reazione di “lotta-fuga”. In pratica, inspirando lentamente dal naso contando ad esempio fino a 4, espandendo l’addome, e poi espirando dalla bocca per un conteggio più lungo (ad esempio fino a 6), il battito cardiaco tende a rallentare, la pressione si regolarizza e la mente riceve un segnale di calma. Eseguire questo esercizio per pochi minuti, magari associandolo a pensieri rassicuranti (come “posso farcela, questo momento passerà”) aiuta spesso a ridurre l’intensità dell’ansia acuta, soprattutto durante un attacco di panico o in una fase di forte stress.
Accanto alla respirazione controllata, le pratiche di mindfulness e il grounding si sono dimostrate valide tecniche psicologiche per gestire l’ansia (Hofmann et al., 2019). La mindfulness consiste nel portare intenzionalmente l’attenzione al momento presente in modo non giudicante: focalizzarsi sul respiro, sulle sensazioni corporee o su ciò che ci circonda, accettando che pensieri e emozioni vadano e vengano senza lasciarsi travolgere. Questa pratica, se coltivata regolarmente, aumenta la consapevolezza di sé e insegna a osservare l’ansia con un certo distacco, riducendone l’impatto. Tecniche di grounding, invece, sono strumenti di ancoraggio al “qui ed ora” particolarmente utili quando l’ansia rischia di sopraffarci o ci sentiamo in uno stato di derealizzazione: ad esempio, guardarsi intorno e descrivere mentalmente cinque cose che vediamo, quattro che possiamo toccare, tre suoni che udiamo, due odori che percepiamo e un gusto in bocca (la tecnica del 5-4-3-2-1), oppure concentrarsi sul sentire i piedi ben piantati a terra. Questi esercizi radicano la persona nel presente e distolgono dall’onda di panico o dai pensieri catastrofici interni.
Oltre alle tecniche “in acuto” per placare i sintomi, esistono strategie di più ampia portata per ridurre l’ansia nel quotidiano. Un approccio fondamentale è quello comportamentale, che include l’esposizione graduale alle situazioni temute. Evitare costantemente ciò che ci spaventa mantiene e anzi rinforza la paura; viceversa, affrontare gradualmente gli stimoli ansiogeni insegna al cervello che possiamo tollerare l’ansia e che le conseguenze temute non si verificano (APA, 2017). L’esposizione va pianificata preferibilmente con l’aiuto di uno psicologo: ad esempio, una persona con fobia dell’aereo potrebbe iniziare guardando immagini di aerei, poi recandosi in aeroporto senza volare, quindi provando un breve volo accompagnata, fino a riuscire a volare autonomamente su tratte più lunghe. Questo lavoro graduale desensibilizza la reazione fobica e si accompagna a un aumento della fiducia in sé stessi. Anche l’esercizio fisico moderato è un alleato prezioso nella gestione dell’ansia: attività come camminare a passo svelto, fare jogging, yoga o nuoto hanno mostrato di ridurre la tensione e l’irrequietezza, migliorare il tono dell’umore e abbassare i livelli basali di ansia (Stubbs et al., 2017). L’attività fisica regolare aiuta a scaricare le energie in eccesso generate dallo stress, favorisce un migliore sonno e, attraverso il rilascio di endorfine, contrasta gli effetti del cortisolo (l’ormone dello stress). È importante scegliere un tipo di esercizio gradito e compatibile con la propria condizione fisica, evitando eccessi che possano portare all’effetto opposto di iper-stimolare il corpo.
Lo **stile di vita** gioca un ruolo non trascurabile sull’ansia. Curare il sonno è prioritario: dormire a sufficienza e con ritmi regolari contribuisce a regolare l’equilibrio neurochimico del cervello e a mantenere sotto controllo l’attivazione emotiva (NICE, 2011). Al contrario, la deprivazione di sonno aumenta l’irritabilità e l’ansia, creando un circolo vizioso. Anche l’alimentazione influisce: una dieta equilibrata, ricca di nutrienti, supporta il sistema nervoso, mentre eccessi di zuccheri raffinati o pasti irregolari possono facilitare cali glicemici che mimano sintomi d’ansia (come tremori e palpitazioni). È consigliabile limitare il consumo di sostanze stimolanti come caffeina e altri eccitanti, specie nei momenti di maggiore ansia: la caffeina, ad esempio, può aumentare la frequenza cardiaca e l’irrequietezza, esacerbando i sintomi ansiosi in soggetti vulnerabili (Clark & Beck, 2020). Anche la nicotina, sebbene molti fumatori la usino illusoriamente per calmarsi, è uno stimolante che a lungo termine peggiora l’ansia e interferisce col sonno, oltre ai noti effetti deleteri sulla salute. Un consumo eccessivo di alcol, d’altra parte, pur avendo un iniziale effetto sedativo sul sistema nervoso, disturba la qualità del sonno e può far aumentare l’ansia “di rimbalzo” il giorno seguente, innescando un pericoloso ciclo di dipendenza. Dunque, moderazione e consapevolezza nell’uso di queste sostanze sono parte integrante di una buona gestione dell’ansia.
In alcuni casi, soprattutto quando l’ansia raggiunge livelli invalidanti, può essere opportuno affiancare alle strategie psicologiche anche interventi farmacologici. Farmaci ansiolitici o antidepressivi specifici (come gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, SSRI) possono aiutare a riequilibrare i neurotrasmettitori implicati nell’ansia e a ridurre i sintomi fino a renderli gestibili, creando una finestra di opportunità per lavorare sulle cause psicologiche sottostanti (Bandelow et al., 2017). È importante sottolineare che la scelta di un trattamento farmacologico va valutata e monitorata da un medico psichiatra e di solito si inserisce all’interno di un piano terapeutico integrato: la combinazione di farmaci e psicoterapia, secondo molte ricerche, può dare risultati migliori nei disturbi d’ansia più gravi (Cuijpers et al., 2014). Per esempio, una persona con disturbo di panico molto acuto potrebbe trarre beneficio da un breve ciclo di benzodiazepine per bloccare il circolo degli attacchi di panico, mentre in parallelo apprende con lo psicologo tecniche di gestione degli attacchi di panico e affronta gradualmente le situazioni temute. L’obiettivo finale rimane comunque quello di acquisire strumenti personali per regolare l’ansia: il farmaco è un supporto temporaneo, non una soluzione definitiva, e andrebbe sospeso gradualmente appena la terapia psicologica consente un’autonoma gestione degli attacchi di panico e degli altri sintomi d’ansia.
terapie psicologiche per affrontare l'ansia
Tra le terapie psicologiche disponibili per i disturbi d’ansia, la ricerca scientifica e le linee guida internazionali evidenziano diverse opzioni efficaci. La Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT) è considerata il trattamento di elezione per molti disturbi d’ansia (APA, 2016; NICE, 2011). La CBT interviene su due fronti: da un lato aiuta la persona a identificare e modificare i pensieri disfunzionali che alimentano l’ansia (come le interpretazioni catastrofiche dei sintomi fisici o le convinzioni di incapacità di fronteggiare certi eventi), dall’altro agisce sui comportamenti di mantenimento, principalmente attraverso tecniche di esposizione graduale e sviluppo di abilità di coping. Ad esempio, nella CBT per il disturbo di panico, la persona impara a ristrutturare i pensieri del tipo “sto per morire” ogni volta che il cuore accelera, sostituendoli con interpretazioni più realistiche (“è solo ansia, passerà”), mentre pratica esercizi per abituarsi alle sensazioni fisiche temute (come girare su se stessi per provocare vertigini controllate e constatare che non sono pericolose). Numerosi studi e meta-analisi confermano l’efficacia della CBT nel ridurre i sintomi d’ansia e nel prevenire le ricadute a lungo termine (Hofmann et al., 2012). Le linee guida NICE (National Institute for Health and Care Excellence) raccomandano la terapia cognitivo-comportamentale come primo intervento per disturbi come l’ansia generalizzata e il panico, dati i robusti risultati clinici e l’ampia evidenza accumulata.
Accanto alla CBT, anche terapie di terza ondata e approcci innovativi stanno dimostrando la loro utilità. L’Acceptance and Commitment Therapy (ACT), ad esempio, è un modello che invita a sviluppare una diversa relazione con i propri stati interni: invece di lottare per eliminare a tutti i costi l’ansia, l’ACT incoraggia l’accettazione delle emozioni difficili e la focalizzazione sui propri valori personali, impegnandosi in azioni significative nonostante la presenza di ansia (Hayes et al., 2016). Diversi studi hanno evidenziato che l’ACT può essere efficace quanto la CBT in alcuni disturbi d’ansia, offrendo un’alternativa valida per chi magari non trae beneficio completo dall’approccio cognitivo tradizionale (A-Tjak et al., 2015). Un altro metodo, particolarmente noto nel trattamento dei traumi ma applicato con successo anche a fobie e ansia da panico, è l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Questo approccio utilizza movimenti oculari guidati o altre forme di stimolazione alternata per facilitare la rielaborazione di ricordi traumatici o sensazioni emotive bloccate: nel contesto delle fobie, ad esempio, può aiutare a “sganciare” la forte reazione di paura da un’esperienza specifica che l’ha originata (Shapiro, 2018). L’EMDR è riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come trattamento efficace per il PTSD, e evidenze emergenti ne supportano l’impiego integrato in alcuni casi di ansia refrattaria (Carletto et al., 2017). In pratica clinica, molti psicologi adottano un approccio **integrato** e personalizzato: ciò significa combinare tecniche diverse (cognitive, comportamentali, corporee, mindfulness) in base alle caratteristiche individuali del paziente e alla natura dei sintomi. Ad esempio, per un paziente con ansia generalizzata si potrà integrare il lavoro sulle preoccupazioni con esercizi di rilassamento muscolare progressivo; per un paziente con fobia sociale, unire tecniche cognitive sulle credenze di inferiorità con sessioni di role-playing per praticare abilità sociali. Le evidenze comparano favorevolmente questi approcci flessibili, suggerendo che ad una elevata **personalizzazione** del trattamento corrisponde spesso un esito migliore (Norcross & Wampold, 2019). In sintesi, non esiste una risposta unica valida per tutti: le tecniche psicologiche vanno adattate alla persona, e lo psicologo decide insieme al paziente quale percorso terapeutico intraprendere, tenendo conto della natura dell’ansia, della gravità, ma anche delle preferenze e della storia individuale.
Cosa fa lo psicologo per affrontare i disturbi d'ansia?
Viene naturale chiedersi, a questo punto, cosa fa concretamente uno psicologo per aiutare chi soffre di ansia. Il percorso tipico inizia con un assessment clinico approfondito: attraverso colloqui, questionari standardizzati e un’ascolto empatico, lo psicologo raccoglie informazioni sulla storia del problema, sui sintomi attuali, sui fattori scatenanti e di mantenimento. Questa fase permette di giungere a una formulazione del caso, ovvero una sorta di “mappa” personalizzata di come l’ansia si è sviluppata e cosa la alimenta, integrando aspetti biologici, psicologici e sociali (modello bio-psico-sociale). Ad esempio, la formulazione potrebbe evidenziare che gli attacchi di panico di una persona sono mantenuti dall’interpretazione catastrofica dei sintomi fisici (fattore psicologico), dalla predisposizione familiare all’ansia (fattore biologico) e dallo stress lavorativo attuale (fattore sociale). Sulla base di questa concettualizzazione condivisa col paziente, si definiscono insieme gli obiettivi terapeutici: spesso obiettivi graduali, realistici e misurabili, come “ridurre la frequenza degli attacchi di panico da più volte a settimana a massimo uno al mese” oppure “riuscire a guidare da solo fino al centro commerciale”. Lo psicologo quindi introduce e insegna progressivamente alla persona specifiche abilità di coping per gestire l’ansia: può trattarsi delle tecniche di respirazione e rilassamento di cui sopra, di tecniche cognitive (identificare i pensieri ansiogeni e sostituirli con pensieri più funzionali), di training attentivi (spostare l’attenzione dall’interno all’esterno per ridurre l’auto-monitoraggio ansioso), o di abilità sociali, se il problema è l’ansia nell’interazione con gli altri.
Una parte importante del lavoro psicologico è il monitoraggio dei progressi: lo psicologo e il paziente verificano insieme, sessione dopo sessione, i cambiamenti nei sintomi e nel funzionamento. Questo può avvenire tramite il racconto di esperienze settimanali, la compilazione di diari dell’ansia o scale di valutazione periodiche. Ad esempio, il paziente con ansia sociale potrebbe tenere nota delle situazioni affrontate e del livello di ansia provato in ciascuna, per poi rivederle in seduta e notare i miglioramenti nel tempo. Il monitoraggio costante consente anche di individuare tempestivamente eventuali ostacoli o un peggioramento, così da adattare la strategia terapeutica di conseguenza. In certi casi, lo psicologo collabora con altri professionisti per garantire un approccio davvero integrato: può suggerire una visita psichiatrica se ritiene che una valutazione farmacologica sia opportuna; oppure, se ci sono concomitanti problematiche mediche (tiroide, disturbi gastrointestinali, dolore cronico) che incidono sull’ansia, incoraggia la persona a un controllo medico e rimane in contatto col medico di base o lo specialista per coordinare gli interventi. Questa collaborazione multidisciplinare è in linea con le raccomandazioni delle linee guida (es. NICE) secondo cui la gestione ottimale dell’ansia, specie se severa, può richiedere il contributo sinergico di psicologi, psichiatri e altre figure della salute (García-Campayo et al., 2017). In ogni caso, l’intervento dello psicologo non si limita a ridurre i sintomi nell’immediato, ma mira a rendere il paziente autonomo nel riconoscere e fronteggiare future manifestazioni d’ansia: si lavora sulla prevenzione delle ricadute, dotando la persona di un “bagaglio” di strategie utilizzabili anche dopo la fine della terapia.
Per comprendere meglio come funzionano le tecniche citate in base ai diversi quadri clinici, può essere utile esplorare alcune differenze nella gestione di ansia, attacchi di panico e fobie attraverso esempi concreti. Immaginiamo una persona che sperimenta attacchi di panico: all’improvviso, senza un motivo apparente, il suo corpo viene travolto da palpitazioni, respiro corto, sudorazione, dolore al petto e una paura intensa di morire o perdere il controllo. In terapia, uno degli obiettivi primari sarà insegnarle a riconoscere i segnali precoci del panico e applicare subito tecniche di autoregolazione emotiva. Ad esempio, al primo accenno di tachicardia imparerà a rallentare il respiro con la respirazione diaframmatica e a utilizzare il grounding per ancorarsi: “OK, sento il cuore accelerato, ma ho già provato questo e so che è l’ansia che arriva; adesso mi concentro sul respiro, guardo attorno a me e noto 5 cose blu nella stanza”. Contemporaneamente, il lavoro cognitivo verterà sul ridurre il terrore dei sintomi fisici: con lo psicologo, la persona esaminerà le prove a favore e contro l’idea “sto per impazzire o avere un infarto”, ricordando magari che in passato il cuore ha sempre rallentato da solo dopo pochi minuti e che gli accertamenti medici erano normali. Piano piano, attraverso tecniche psicologiche come l’esposizione interocettiva (provocare volontariamente, in modo sicuro, alcune sensazioni temute come iperventilare leggermente per sentire il formicolio e apprendere che pur essendo sgradevole non è pericoloso), la persona con disturbo di panico riacquista fiducia: capisce di poter interrompere l’escalation dell’ansia e che un attacco, se arriva, può essere gestito senza catastrofi. La gestione degli attacchi di panico diventa così sempre più efficace e il soggetto torna gradualmente a svolgere attività prima evitate, come guidare o frequentare luoghi affollati, mettendo in pratica le nuove abilità apprese.
Consideriamo ora una fobia specifica, ad esempio la fobia dei cani. Qui l’ansia si manifesta come paura intensa e mirata ogni volta che la persona vede o anticipa di vedere un cane, magari anche solo sentendo abbaiare in lontananza. L’evitamento è spesso totale: chi ne soffre può fare giri larghissimi per non passare vicino a un cane al parco, o rinunciare a visitare amici che hanno un animale domestico. In terapia, dopo aver appreso le tecniche di base per calmarsi (simili a quelle già descritte: respirazione, grounding mentale, ecc.), il fulcro dell’intervento sarà l’esposizione graduale in vivo. Con il supporto dello psicologo, la persona costruisce una gerarchia delle situazioni temute – ad esempio, guardare foto di cani, vedere un cane al guinzaglio da 30 metri, da 10 metri, stare nella stessa stanza con un cucciolo tranquillo, accarezzare un cane di piccola taglia, e così via – e le affronta una per volta. Ogni passo, inizialmente, genera ansia, ma applicando le tecniche di autoregolazione e rimanendo abbastanza a lungo nella situazione (senza fuggire), l’ansia inizia a calare da sola: è il fenomeno dell’abituazione. Dopo varie ripetizioni, il cervello “impara” che il cane non è una minaccia così terribile e la reazione fobica diminuisce drasticamente in intensità. L’esposizione nelle fobie è considerata il trattamento più efficace, con tassi di successo molto elevati quando condotta in maniera sistematica (Wolitzky-Taylor et al., 2008). Lo psicologo arricchisce questo lavoro pratico con elementi cognitivi (ad esempio esplorando eventuali credenze esagerate, come “tutti i cani vogliono attaccarmi”) e con un rinforzo dell’autoefficacia: ogni volta che il paziente supera un livello della gerarchia, si sottolinea il progresso compiuto e la prova concreta della propria capacità di gestire la paura.
Nel caso dell’ansia sociale, la sfida principale è spezzare il circolo vizioso tra la paura del giudizio altrui, l’auto-osservazione e l’evitamento delle situazioni sociali. Qui la tecnica dell’esposizione prende la forma di una esposizione in situazione: il paziente viene gradualmente incoraggiato a mettersi nelle condizioni temute (ad esempio avviare una conversazione con uno sconosciuto, o tenere un breve discorso in una riunione di lavoro) e successivamente, insieme al terapeuta, analizza cosa è accaduto davvero rispetto a ciò che temeva. Spesso si rende conto che le proprie predizioni catastrofiche (“arrossirò e tutti rideranno di me”) non si realizzano o che, anche se c’è stato un po’ di disagio, gli altri non lo hanno disprezzato come immaginava. Lo psicologo può utilizzare strumenti come il role playing in seduta – simulando una piccola situazione sociale ansiogena per allenarsi – e lavorare sui pensieri di autovalutazione negativa cronica (“non valgo, sono noioso, tutti mi giudicano male”), tipici dell’ansia sociale. Le tecniche cognitive-comportamentali per l’ansia sociale hanno dimostrato efficacia paragonabile a quelle per il panico e le fobie, con miglioramenti sia nella sintomatologia ansiosa sia nella qualità di vita sociale riferita dal paziente (Clark et al., 2006). In parallelo, se appropriato, si possono introdurre elementi di training assertivo o di comunicazione, per dotare il paziente di maggior sicurezza nell’esprimersi e gestire eventuali critiche, completando così il ventaglio di abilità utili ad affrontare il contesto sociale.
Da questi esempi è evidente che, pur declinandosi in modalità specifiche per ogni disturbo, le strategie di base – riconoscere i sintomi, regolare l’attivazione corporea, esporre gradualmente alle situazioni temute, ristrutturare i pensieri disfunzionali – costituiscono uno schema comune per affrontare l’ansia in tutte le sue forme. La chiave è adattare l’intervento alla persona e al problema: l’ansia ha molte facce, e il trattamento deve essere sartoriale, cucito su misura in base alle necessità individuali.
Come affrontare l'ansia
Affrontare l’ansia richiede un approccio integrato mente-corpo che unisca conoscenze scientifiche, tecniche pratiche e sensibilità personale. Abbiamo visto come distinguere l’ansia fisiologica da quella patologica e identificare i vari volti dei disturbi d’ansia – dal panico alle fobie – sia il primo passo per intervenire in modo mirato. Riconoscere i sintomi somatici, cognitivi ed emotivi dell’ansia consente di attivare precocemente gli strumenti di autoregolazione emotiva: dalla respirazione diaframmatica alla mindfulness, dal grounding all’esercizio fisico, supportati da sane abitudini di vita, queste tecniche aiutano a calmare la mente e il corpo quando l’ansia prende il sopravvento. Parallelamente, le tecniche psicologiche validate – in primis la terapia cognitivo-comportamentale, affiancata da ACT, EMDR e altri approcci integrati – offrono percorsi strutturati per modificare in profondità i meccanismi dell’ansia, con effetti duraturi sul benessere. Abbiamo sottolineato l’importanza della psicoeducazione e della comprensione della neurofisiologia dello stress: sapere che l’ansia ha una base biologica (il sistema “lotta o fuga”) e che possiamo influenzarla attivamente con il respiro, il rilassamento e il cambiamento dei pensieri, restituisce alle persone un senso di controllo e speranza. Inoltre, comprendere gli effetti a lungo termine dello stress cronico sul corpo – come la stanchezza, i disturbi immunitari o cardiovascolari associati a un’iper-attivazione ansiosa protratta – motiva a prendersi cura di sé prima che l’ansia mini seriamente la salute.
Lungo questo itinerario, il ruolo dei professionisti qualificati è centrale: psicologi e psicoterapeuti forniscono una guida esperta, empatica e scientificamente fondata per aiutare chi soffre di ansia a ritrovare l’equilibrio, mentre psichiatri e medici possono contribuire nella gestione farmacologica o nel trattamento di eventuali condizioni mediche correlate. Come abbiamo visto, l’ansia non è “tutta nella testa”, ma coinvolge mente e corpo; per questo un approccio integrato, che consideri la globalità della persona, è il più indicato. Affrontare l’ansia significa intraprendere un percorso di conoscenza di sé e di crescita personale: imparare a riconoscere le proprie emozioni, accoglierle senza esserne sopraffatti e rispondere con azioni consapevoli. Con gli strumenti giusti – dalle tecniche di rilassamento alle psicoterapie evidence-based – e con il sostegno di professionisti della salute mentale, è possibile non solo gestire gli attacchi di panico, le preoccupazioni e le paure, ma anche trasformare l’ansia da nemica incontrollabile in una segnale, un messaggero da ascoltare e comprendere. In questo modo, la persona riprende in mano le redini del proprio benessere psicologico, ritrovando la capacità di vivere con maggiore serenità, fiducia e pienezza le sfide di ogni giorno.
Fonti: Clark, D.A., & Beck, A.T. (2020). Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. **APA** – American Psychiatric Association (2013). DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. APA (2016). Linee guida per il trattamento evidence-based dei disturbi d’ansia. NICE – National Institute for Health and Care Excellence (2011). Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (Clinical guideline 113). Hofmann, S.G., et al. (2012). The Efficacy of CBT for Anxiety Disorders: A Meta-Analysis. Norcross, J.C., & Wampold, B.E. (2019). Evidence-based therapy relationships: Research conclusions and clinical practices. Bandelow, B., et al. (2017). Efficacy of treatments for anxiety disorders: a meta-analysis. A-Tjak, J.G., et al. (2015). Meta-analysis of the effectiveness of ACT in treating anxiety disorders. Shapiro, F. (2018). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapy: Basic principles, protocols, and procedures. García-Campayo, J., et al. (2017). Multidisciplinary approach to anxiety disorders. Bourne, E.J. (2020). The Anxiety & Phobia Workbook. Stubbs, B., et al. (2017). EPA Guidelines on physical activity as a treatment for depression and anxiety. Wolitzky-Taylor, K.B., et al. (2008). Meta-analysis: The efficacy of behavior therapies for phobias. Hayes, S.C., et al. (2016). Acceptance and Commitment Therapy: Processes and Outcomes. Clark, D.M., et al. (2006). Cognitive therapy vs interpersonal therapy in social anxiety disorder.
L’Alimentazione dello Sportivo: tra Energia, Performance e Salute
L'alimentazione sportiva
L’alimentazione sportiva è un pilastro fondamentale per chi conduce uno stile di vita attivo, collocandosi al crocevia tra energia e performance ottimali e la tutela della salute. Un atleta, sia esso amatoriale o competitivo, non può affidarsi al caso per nutrire il proprio corpo: ciò che mangia influisce direttamente sulla capacità di allenarsi efficacemente, migliorare la performance e recuperare, oltre che sul mantenimento della salute nello sport e nel lungo termine. Diversi studi recenti confermano che una dieta adeguata al tipo di attività fisica praticata migliora i risultati atletici e riduce i rischi di infortunio (Thomas et al., 2016; Smith et al., 2023). In questo articolo analizzeremo come la nutrizione possa essere adattata in base all’intensità e alla durata dell’esercizio, al tipo di sport praticato e al periodo della stagione sportiva, esaminando i principi nutritivi chiave (macronutrienti, micronutrienti, idratazione) e il ruolo del timing nutrizionale. Infine, discuteremo dell’importanza di alimentazione e attività fisica per la salute globale e prenderemo in considerazione alcune integrazioni alimentari evidenziando le situazioni in cui possono essere utili, sempre sulla base delle più recenti evidenze scientifiche.
Fabbisogni di macro e micronutrienti in base allo sport praticato
Ogni sportivo deve soddisfare requisiti nutrizionali specifici, che variano in base alla disciplina praticata, all’intensità e alla durata dell’esercizio. I macronutrienti – carboidrati, proteine e grassi – forniscono energia e materiali di costruzione per l’organismo, mentre i micronutrienti – come vitamine e minerali – supportano innumerevoli processi biochimici ed erano essenziali per il metabolismo energetico cellulare. Una caratteristica fondamentale dell’alimentazione sportiva efficace è il giusto equilibrio tra questi nutrienti, tarato sulle esigenze dell’atleta (Burke et al., 2018). Ad esempio, un corridore di maratona che si allena molte ore la settimana avrà un fabbisogno elevato di carboidrati per mantenere pieni i depositi di glicogeno muscolare, la “benzina” primaria per sforzi prolungati ad intensità medio-alta (Cermak & van Loon, 2013). Al contrario, un sollevatore di pesi o un velocista, impegnati in sforzi brevi e molto intensi, daranno priorità a un apporto proteico superiore per favorire la riparazione e la crescita muscolare, pur senza trascurare i carboidrati che restano importanti anche in sport di potenza per sostenere i picchi di energia e performance (Phillips et al., 2014).
Diversi studi dimostrano come la ripartizione dei macronutrienti debba adattarsi al tipo di esercizio. Nelle discipline di endurance (resistenza) come corsa di fondo, ciclismo o nuoto di lunga distanza, è raccomandato che i carboidrati costituiscano la quota prevalente dell’energia giornaliera (dal 55% fino al 65-70% in periodi di carico intenso) per sostenere l’elevato dispendio energetico e prevenire l’esaurimento precoce delle riserve di glicogeno (Burke et al., 2019). In questi atleti di endurance, l’apporto di carboidrati può raggiungere e superare 7-10 grammi per kg di peso corporeo nei giorni di allenamento più intenso (Thomas et al., 2016). Al contempo, il fabbisogno proteico pur essendo moderatamente aumentato rispetto a una persona sedentaria (indicativamente 1,2-1,6 g/kg), rimane inferiore a quello necessario in sport di forza, e serve principalmente a riparare i micro-danni muscolari causati dall’esercizio prolungato e a sostenere le funzioni enzimatiche (Phillips et al., 2016). Negli sport di potenza e forza come sollevamento pesi, sprint, gare di salto o bodybuilding, i muscoli sono sottoposti a sforzi esplosivi e intensi: qui le proteine diventano il macronutriente di spicco per supportare la sintesi proteica muscolare e l’adattamento allo sforzo. Si consigliano apporti proteici maggiori (anche 1,6-2,2 g/kg al dì, secondo l’intensità dell’allenamento) per massimizzare l’ipertrofia e favorire il recupero (Jäger et al., 2017). In queste discipline di potenza i carboidrati restano comunque importanti per fornire energia rapida durante gli allenamenti anaerobici e consentire lavori esplosivi ripetuti, ma spesso costituiscono una percentuale leggermente inferiore della dieta rispetto agli sport di endurance (ad esempio 45-55% delle calorie). I grassi, infine, rappresentano una fonte energetica concentrata e indispensabile per l’atleta: in genere dovrebbero coprire circa il 20-30% dell’apporto calorico in qualunque disciplina (Thomas et al., 2016). Negli sport di durata molto prolungata, l’organismo attinge gradualmente in misura crescente ai grassi come carburante, specialmente a intensità medio-basse; inoltre i grassi alimentari forniscono acidi grassi essenziali come gli omega-3 (importanti per le membrane cellulari e l’azione antinfiammatoria) e servono per assorbire vitamine liposolubili cruciali per la salute.
Parallelamente ai macronutrienti, i micronutrienti svolgono un ruolo chiave nel supportare la performance e il benessere dell’atleta. Vitamine e minerali non apportano calorie, ma senza di essi il corpo non potrebbe convertire in modo efficiente i carboidrati, i grassi e le proteine in energia utilizzabile né mantenere l’omeostasi durante l’attività fisica intensa. Ad esempio, le vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B6, B12) sono cofattori essenziali nelle vie metaboliche che portano alla produzione di ATP, la molecola energetica utilizzata dai muscoli durante la contrazione: una dieta povera di vitamine B può compromettere la capacità di energia e performance ottimali, causando affaticamento precoce (Woolf & Manore, 2006). Minerali come il ferro e il calcio sono particolarmente critici per chi pratica sport. Il ferro, componente fondamentale dell’emoglobina nel sangue e della mioglobina nei muscoli, consente il trasporto dell’ossigeno alle cellule: livelli inadeguati di ferro (ad esempio in caso di anemia da carenza di ferro) riducono significativamente la resistenza e la capacità di lavoro muscolare, e sono una problematica comune tra gli atleti di endurance, specialmente donne (Sim et al., 2019). Il calcio, insieme alla vitamina D, è essenziale per la salute dell’apparato scheletrico e per la contrazione muscolare; negli atleti sottoposti a stress osseo ripetitivo (come i corridori) un insufficiente apporto di calcio e vitamina D può predisporre a fratture da stress e infortuni (Lappe et al., 2017). Altri micronutrienti chiave includono il magnesio (cofattore in reazioni energetiche e nella trasmissione neuromuscolare), il potassio e il sodio (elettroliti che regolano l’equilibrio idrico, la funzione muscolare e nervosa, fondamentali per mantenere l’idratazione e prevenire crampi durante lo sforzo). Un atleta deve quindi curare un apporto adeguato di frutta, verdura, cereali integrali e altri alimenti ricchi di vitamine e minerali, eventualmente valutando – sotto supervisione professionale – integrazioni mirate se vengono riscontrate carenze specifiche.
Timing nutrizionale: energia prima, durante e dopo l’allenamento
Non è solo la qualità e la quantità dei nutrienti a influenzare la performance sportiva: il momento in cui vengono assunti gioca un ruolo cruciale nel massimizzare l’energia disponibile, sostenere la performance e favorire il recupero. Il concetto di timing nutrizionale si riferisce alla distribuzione strategica dell’introito di carboidrati, proteine, grassi e liquidi nei periodi pre-, intra- e post-allenamento, con l’obiettivo di ottimizzare gli adattamenti all’esercizio e ridurre i tempi di recupero (Kerksick et al., 2017).
Prima dell’esercizio, l’obiettivo principale dell’alimentazione è garantire all’organismo un’adeguata riserva di energia ed evitare sensazioni di fame o discomfort gastrointestinale durante lo sforzo. Il pasto pre-allenamento andrebbe consumato nelle 2-3 ore precedenti l’attività e dovrebbe essere composto prevalentemente da carboidrati a medio-basso indice glicemico (per fornire energia graduale e costante), da una quota moderata di proteine facilmente digeribili e da pochi grassi e fibre, che rallenterebbero troppo la digestione (Burke et al., 2019). Un esempio può essere un pasto leggero a base di riso o pasta con un condimento leggero e una fonte proteica magra, oppure yogurt con cereali e frutta. Studi scientifici hanno evidenziato che consumare carboidrati prima dell’attività aumenta la disponibilità di glucosio nel sangue e nei muscoli, migliorando la capacità di esercizio soprattutto nelle prove di endurance prolungate (Smith et al., 2020). Inoltre, introdurre una piccola quantità di proteine pre-allenamento può favorire l’anabolismo muscolare già durante l’esercizio e attenuare il catabolismo, cioè la demolizione delle proteine muscolari indotta dallo sforzo (Hackney et al., 2020).
Durante l’esercizio, le strategie nutrizionali dipendono molto dalla durata e dall’intensità dell’allenamento o gara. In attività brevi (fino a 60 minuti) e di intensità moderata, la priorità è mantenere una buona idratazione: è consigliabile bere acqua a piccoli sorsi, iniziando prima di avvertire lo stimolo della sete, perché anche una lieve disidratazione (ad esempio del 2% del peso corporeo) può ridurre la performance cognitiva e fisica (Cheuvront & Kenefick, 2017). In sforzi prolungati oltre l’ora, specie se a intensità elevata o in ambienti caldi, l’organismo beneficia anche dell’apporto di carboidrati e elettroliti durante l’attività. Le linee guida suggeriscono un consumo di circa 30-60 grammi di carboidrati all’ora per esercizi di durata 1-2 ore (ad esempio bevande sportive contenenti maltodestrine o gel energetici), quantità che può salire fino a 90 g/ora in eventi ultra-endurance di molte ore, sempre associando un’adeguata quota di liquidi (Thomas et al., 2016). L’assunzione di carboidrati durante l’esercizio aiuta a mantenere stabili la glicemia e l’ossidazione di glucosio da parte dei muscoli, ritardando l’insorgere della fatica e sostenendo la performance prolungata (Cox et al., 2010). Non meno importante, reintegrare il sodio e altri elettroliti persi con il sudore durante lo sforzo intenso (specialmente in condizioni di caldo) previene squilibri idro-elettrolitici che potrebbero causare crampi, cali di pressione o colpi di calore. In attività molto brevi e intense (ad esempio uno sprint di pochi minuti o una sessione di sollevamento pesi sotto l’ora) invece, di solito non è necessario introdurre nutrienti durante lo sforzo, ad eccezione dell’acqua: l’organismo utilizza le riserve energetiche già disponibili (glicogeno muscolare e epatico) e qualsiasi pasto durante l’attività sarebbe pratico solo se l’intervallo di tempo lo consente (come nelle pause di sport di squadra di lunga durata, ad esempio una partita di calcio durante l’intervallo).
Il post-allenamento rappresenta una finestra temporale cruciale per il recupero: nei 30-60 minuti successivi alla fine dell’attività fisica, i muscoli sono particolarmente ricettivi nell’assorbire nutrienti utili a ripristinare le riserve energetiche e a riparare i tessuti. In questa fase è consigliabile assumere una combinazione di carboidrati e proteine di rapido assorbimento. I carboidrati ad alto indice glicemico favoriscono la sintesi di glicogeno, rifornendo i muscoli del carburante speso; le proteine forniscono aminoacidi necessari a ricostruire le fibre muscolari e stimolano la sintesi proteica, processo alla base dell’adattamento e del rafforzamento muscolare (Ivy et al., 2017). La ricerca mostra che consumare ~20-30 g di proteine di alta qualità (contenenti tutti gli aminoacidi essenziali, ad esempio proteine del siero del latte, uova o una combinazione di cereali e legumi per i vegetariani) insieme a una fonte di carboidrati entro un’ora dall’allenamento migliora significativamente il recupero e favorisce gli adattamenti positivi dell’allenamento, rispetto a rinviare troppo l’assunzione di nutrienti (Aragon & Schoenfeld, 2013; Morton et al., 2018). Inoltre, reintegrare i liquidi persi è fondamentale: per ogni chilogrammo di peso perso durante l’esercizio (misurato pesandosi prima e dopo), è raccomandabile bere circa 1,2-1,5 litri di acqua o bevande con sali minerali nel post-allenamento, così da compensare le perdite idriche e favorire una reidratazione completa (McDermott et al., 2017). Un adeguato refuel post esercizio non solo rigenera le scorte energetiche e costruisce nuovo tessuto muscolare, ma contribuisce anche a ridurre il rischio di infortuni e sovrallenamento: atleti che trascurano il recupero nutrizionale presentano più frequentemente problemi muscolari, cali delle difese immunitarie e sindromi da affaticamento (Nieman & Wentz, 2019).
Nutrienti ed energia: il ruolo di carboidrati, proteine, grassi, micronutrienti e idratazione
Dopo aver esaminato il quando nutrirsi, è importante approfondire il cosa mangiare: ogni categoria di nutrienti svolge funzioni specifiche a supporto dell’energia, della performance e della salute dell’atleta. I carboidrati, come già evidenziato, rappresentano la fonte energetica più immediata. Durante l’esercizio, il glucosio derivato dai carboidrati alimentari e il glicogeno immagazzinato nel fegato e nei muscoli vengono ossidati nelle cellule muscolari tramite la glicolisi e il ciclo di Krebs, processi metabolici che producono ATP, la molecola che fornisce energia immediata alla contrazione muscolare. Una disponibilità insufficiente di carboidrati può portare all’esaurimento del glicogeno e alla comparsa del classico “calo di energia” o bonking, con drastico peggioramento della performance (Coyle, 2004). Pertanto, per l’atleta medio si raccomanda che una porzione significativa delle calorie derivi da carboidrati complessi di buona qualità – cereali integrali, patate, riso, pasta, frutta – modulandone la quantità in base al volume di allenamento giornaliero (Thomas et al., 2016).
Le proteine sono i mattoni costitutivi dei tessuti, in particolare dei muscoli, e svolgono un ruolo chiave nel recupero e nell’adattamento all’allenamento. Gli aminoacidi che le compongono partecipano anche a molti processi enzimatici e ormonali. Durante l’attività di forza o in allenamenti intensi, si verificano microlesioni delle fibre muscolari che l’organismo ripara e rinforza durante il recupero grazie alla sintesi di nuove proteine muscolari: affinché ciò avvenga, è necessario un apporto sufficiente di aminoacidi essenziali tramite la dieta (Phillips et al., 2016). Inoltre, un adeguato consumo proteico aiuta a prevenire la perdita di massa magra nei periodi di allenamento intenso o di restrizione calorica. Fonti proteiche di alta qualità includono carni magre, pesce, uova, latticini, legumi e derivati della soia; gli sportivi dovrebbero distribuirle nell’arco della giornata, includendo una dose di proteine in ogni pasto principale e in eventuali spuntini post-allenamento (Morton et al., 2018). Va sottolineato che oltre una certa soglia (circa 2,2 g/kg di peso, salvo casi particolari) l’eccesso proteico non porta benefici ulteriori alla sintesi muscolare e rischia anzi di sovraccaricare inutilmente i reni e il fegato con i prodotti di scarto del metabolismo aminoacidico (Phillips et al., 2016). L’equilibrio è quindi fondamentale.
I grassi alimentari, spesso temuti ingiustamente, sono in realtà indispensabili per lo sportivo tanto quanto per la popolazione generale. Essi forniscono acidi grassi essenziali (come omega-3 e omega-6) che il corpo non può sintetizzare da sé e che partecipano alla modulazione dell’infiammazione, alla salute cardiovascolare e cerebrale. I grassi sono anche necessari per l’assorbimento delle vitamine A, D, E e K e per la produzione di ormoni (inclusi quelli anabolici come il testosterone). Dal punto di vista energetico, i lipidi garantiscono il combustibile predominante per sforzi di lunga durata a bassa intensità: un atleta ultra-maratoneta in competizione, dopo alcune ore di corsa, ottiene una percentuale significativa del suo ATP dalla β-ossidazione degli acidi grassi nei mitocondri muscolari (Brooks & Mercier, 1994). Ciò non significa che debba adottare diete estreme ad alto contenuto di grassi e bassi carboidrati – l’equilibrio resta fondamentale – ma piuttosto che non deve scendere sotto una certa quota lipidica: diete troppo povere di grassi (<15% delle calorie) sono sconsigliate, poiché possono portare a squilibri ormonali e carenze nutrizionali (Mountjoy et al., 2018). È invece opportuno preferire grassi “buoni” insaturi (olio extravergine d’oliva, frutta secca, pesce azzurro, avocado) limitando i grassi saturi in eccesso e i trans, che a lungo termine nuocciono alla salute cardiometabolica.
I micronutrienti – pur necessari in piccole quantità – ricoprono ruoli nei processi energetici e nel mantenimento della performance. Abbiamo già menzionato alcuni esempi come il ferro, il calcio e le vitamine del gruppo B. Possiamo aggiungere la vitamina C e la vitamina E, antiossidanti che contribuiscono a neutralizzare i radicali liberi prodotti durante l’esercizio intenso, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo. Tuttavia, è interessante osservare che un eccesso di supplementazione antiossidante potrebbe attenuare alcuni adattamenti positivi all’allenamento (Gomez-Cabrera et al., 2015); perciò l’atleta dovrebbe puntare ad ottenere vitamine e antiossidanti principalmente attraverso una dieta varia ricca di vegetali, e ricorrere agli integratori vitaminici solo in caso di accertata necessità. Altri micronutrienti importanti includono lo zinco (coinvolto nel sistema immunitario e nella riparazione dei tessuti), il selenio (antiossidante, sostiene la funzione tiroidea) e il magnesio, già citato, che partecipa a oltre 300 reazioni enzimatiche tra cui quelle per la produzione di energia. Ogni micronutriente ha una funzione specifica: ad esempio una carenza di potassio o magnesio può manifestarsi con crampi muscolari e affaticabilità, mentre una deficienza di vitamina B12 (rischiosa in diete vegane non integrate) causa anemia megaloblastica e sintomi da ridotta ossigenazione muscolare. Pertanto, l’atleta deve assicurarsi di soddisfare il proprio fabbisogno di vitamine e minerali attraverso un’alimentazione equilibrata e, se necessario, con l’aiuto di un professionista, valutare integrazioni personalizzate.
L’idratazione merita un richiamo particolare: l’acqua è il veicolo in cui avvengono tutte le reazioni biochimiche nel corpo, inclusi i processi di produzione di energia all’interno delle cellule muscolari. Uno stato di disidratazione, anche lieve, compromette il volume plasmatico, riduce l’apporto di sangue (e quindi di ossigeno e nutrienti) ai muscoli e influisce negativamente sulla capacità termoregolatoria. Conseguentemente, la performance atletica ne soffre e aumenta il rischio di colpi di calore, soprattutto negli sport di endurance e in ambienti caldi (Casa et al., 2015). Bere adeguatamente durante tutta la giornata e aumentare l’apporto di liquidi in prossimità dell’esercizio (senza esagerare per non incorrere in iponatriemia da eccesso d’acqua) è parte integrante di un’alimentazione sportiva corretta. Le strategie di idratazione vanno dal semplice consumo regolare di acqua, sufficiente per attività leggere o moderate, fino a bevande contenenti sali minerali e una piccola percentuale di carboidrati per esercizi di lunga durata, al fine di rimpiazzare le perdite con il sudore. In sintesi, carboidrati, proteine, grassi, micronutrienti e acqua agiscono in sinergia nel sostenere le esigenze energetiche cellulari dell’atleta: solo bilanciando opportunamente tutti questi elementi è possibile allenarsi e competere al meglio, mantenendo allo stesso tempo uno stato di salute ottimale.
Alimentazione e attività fisica come binomio per la salute globale
Un corretto stile alimentare abbinato all’attività fisica regolare non si riflette solo su tempi più veloci o muscoli più forti: rappresenta uno dei fondamenti per la salute globale dell’individuo. Numerose evidenze scientifiche indicano che nutrizione e movimento agiscono in maniera complementare nel rafforzare il corpo e prevenire molte patologie, oltre a influenzare positivamente la salute mentale e la longevità (Warburton & Bredin, 2017). Dal punto di vista del sistema immunitario, ad esempio, un esercizio fisico moderato e costante è associato a una migliore funzione delle difese immunitarie; tuttavia, allenamenti estremamente intensi o prolungati possono temporaneamente indebolire l’immunità, aprendo quella che viene definita la “finestra immunitaria” in cui aumenta il rischio di infezioni (Nieman & Wentz, 2019). Ecco che entra in gioco l’alimentazione: garantire un adeguato apporto calorico e di nutrienti, specialmente carboidrati e proteine, immediatamente dopo un esercizio intenso contribuisce a mitigare l’impatto negativo sul sistema immunitario, riducendo la produzione degli ormoni dello stress e fornendo substrati utili al recupero delle cellule immunitarie (Walsh, 2019). Nutrienti come le vitamine A, C, E e lo zinco sono noti per supportare la funzione immunitaria e, sebbene in genere possano essere ottenuti da una dieta variata, in atleti sottoposti a stress fisiologico elevato è cruciale monitorarne i livelli per evitare che piccole carenze compromettano la risposta immunitaria.
L’alimentazione equilibrata e lo sport sono imprescindibili anche per mantenere una composizione corporea sana. L’esercizio regolare, soprattutto se include attività di forza, aiuta a incrementare o preservare la massa muscolare e a controllare la massa grassa; parallelamente una dieta adeguata fornisce l’energia necessaria per l’allenamento senza eccedere, in modo da evitare l’accumulo adiposo indesiderato. Un regime alimentare strutturato sulle esigenze dell’atleta consente di raggiungere e mantenere il peso forma ideale per la propria disciplina – ad esempio un corridore di lunghe distanze avrà necessità di essere leggero ma con sufficienti riserve energetiche, mentre un rugbista punterà a una maggiore massa muscolare – il tutto senza compromettere la salute. Ciò ha effetti diretti sulla prevenzione di malattie metaboliche: l’associazione di dieta corretta e attività fisica riduce drasticamente il rischio di obesità, diabete di tipo 2, ipertensione e altre patologie cardiovascolari (Blair & Morris, 2009). Anche chi pratica sport a livello non agonistico ricava benefici per la salute cardiovascolare: l’esercizio migliora l’efficienza del cuore e la circolazione, e nutrienti come gli acidi grassi omega-3 contribuiscono a ridurre l’infiammazione sistemica e a mantenere elastiche le arterie, dimostrandosi protettivi verso il sistema cardiocircolatorio (O’Keefe et al., 2019).
Un aspetto spesso trascurato ma di grande importanza è l’impatto di alimentazione e attività fisica sulla salute mentale. L’esercizio fisico è riconosciuto per i suoi effetti benefici sull’umore: durante l’attività vengono rilasciate endorfine e altri neurotrasmettitori che favoriscono sensazioni di benessere e riducono stress e ansia. A sua volta, una nutrizione ottimale sostiene la funzione cerebrale fornendo nutrienti necessari per la sintesi di neurotrasmettitori (si pensi agli omega-3 per le membrane neuronali, o alle vitamine del gruppo B e ai carboidrati per un corretto metabolismo energetico cerebrale) e contribuendo a regolare l’asse dello stress attraverso la salute intestinale e l’equilibrio glicemico (Sander et al., 2019). Studi longitudinali hanno trovato che individui che combinano un’attività fisica costante con una dieta di alta qualità (ad esempio ricca di vegetali, frutta, pesce, cereali integrali, con moderato apporto di carne e zuccheri) mostrano tassi più bassi di depressione e un miglioramento del benessere psicologico (Firth et al., 2020). Inoltre, prendersi cura del proprio corpo attraverso sport e alimentazione può rafforzare l’autostima e la percezione di autoefficacia, creando un circolo virtuoso di benessere psicofisico.
Infine, il binomio alimentazione-attività fisica è un investimento a lungo termine sulla longevità. Evidenze demografiche dalle cosiddette Blue Zones (regioni del mondo con inusuale concentrazione di centenari in salute) suggeriscono che uno stile di vita attivo e un’alimentazione equilibrata e moderata sono fattori comuni associati a una vita più lunga e in salute (Pes et al., 2013). Ricerche epidemiologiche hanno quantificato che praticare regolarmente esercizio di intensità moderata può aggiungere anni alla vita, riducendo la mortalità generale; gli effetti sono amplificati quando all’attività motoria si abbina un’alimentazione ricca di nutrienti protettivi come fibre, grassi insaturi e antiossidanti (Lear et al., 2017). In pratica, nutrirsi bene per alimentare l’allenamento non significa solo performare meglio nelle proprie gare o sessioni in palestra, ma anche proteggere la propria salute futura, mantenendo organi e tessuti più giovani e funzionali e prevenendo il declino cognitivo e fisico tipico dell’invecchiamento.
Adattare la dieta allo stile di vita attivo e alle fasi della stagione sportiva
Così come i programmi di allenamento variano tra diverse discipline sportive e fasi dell’anno agonistico, anche il piano nutrizionale va adattato per sostenere al meglio lo stile di vita attivo in ogni situazione. Non esiste un’unica dieta valida per tutti gli sportivi: un approccio personalizzato, basato sul tipo di sport e sugli obiettivi stagionali, è fondamentale per rispondere alle esigenze specifiche di energia, performance e recupero di ciascuno.
Un atleta di endurance, come un maratoneta o un ciclista su lunghe distanze, in genere affronterà volumi di allenamento molto elevati, specialmente in preparazione alle gare. Il suo piano alimentare dovrà quindi essere ricco di carboidrati complessi per soddisfare l’ingente dispendio calorico: ad esempio, durante un ciclo di allenamento settimanale da 100 km di corsa, il maratoneta inserirà porzioni abbondanti di pasta, riso, patate, pane integrale e frutta in quasi ogni pasto, combinandoli con proteine magre e grassi buoni. In prossimità di una gara importante, molti endurance athlete praticano il carbo-loading (caricamento di carboidrati) aumentando ulteriormente la percentuale di carboidrati nei 2-3 giorni prima dell’evento, per massimizzare le scorte di glicogeno muscolare (Burke et al., 2011). D’altro canto, durante i periodi di scarico o di off-season (fuori stagione), quando il chilometraggio e l’intensità degli allenamenti diminuiscono, anche l’apporto calorico complessivo e la quota di carboidrati andranno ridotti per evitare aumenti di peso indesiderati, pur mantenendo un buon apporto proteico per preservare la massa muscolare. Ad esempio, un ciclista professionista può passare da consumare 5000 kcal nei giorni di allenamento intenso a 2500-3000 kcal nell’off-season, modulando le porzioni e introducendo più alimenti a bassa densità energetica (verdure, proteine magre) per controllare l’introito calorico mantenendo la sazietà.
Negli sport di potenza o forza (come sollevamento pesi, powerlifting, sprint, lancio) l’obiettivo primario nutrizionale è spesso supportare la costruzione muscolare e la potenza. Qui la dieta sarà relativamente più ricca di proteine di alto valore biologico, distribuite uniformemente nei pasti per massimizzare la sintesi muscolare. Un esempio pratico: un pesista di 80 kg potrebbe puntare a circa 160 g di proteine al giorno, suddivise in 4 pasti da ~40 g ciascuno, provenienti da carni bianche, pesce, uova, latticini e legumi (Jäger et al., 2017). Contestualmente, i carboidrati verranno assunti in quantità adeguate a sostenere gli allenamenti anaerobici: se l’atleta ha doppie sessioni di strength training in una giornata, curerà un buon rifornimento di glicogeno con pasti ricchi di carboidrati nelle ore che precedono i workout e recuperi post-allenamento con carboidrati e proteine. Durante la pre-season (preparazione), un atleta di forza potrebbe aumentare leggermente l’apporto calorico – in particolare da proteine e carboidrati – per favorire incrementi di massa muscolare (fase di bulking controllato), mentre in prossimità di una gara potrebbe necessitare di ridurre il grasso corporeo per rientrare in una categoria di peso o migliorare il rapporto potenza/peso: in quel caso seguirà per un periodo limitato una dieta ipocalorica moderata (cut), stando attento però a mantenere proteine elevate per non perdere troppa massa magra (Helms et al., 2014). Nell’off-season, anche per sport di forza vi è solitamente un periodo di recupero attivo dove l’atleta può ridurre leggermente l’intensità degli allenamenti e seguire una dieta di mantenimento, concedendosi magari più varietà di cibi e qualche strappo in più, pur continuando a controllare qualità e quantità per non vanificare i progressi compiuti.
Le discipline miste – come gli sport di squadra (calcio, basket, rugby) o arti marziali e crossfit – combinano sforzi di resistenza e scatti di potenza. In questi casi la dieta deve bilanciare entrambe le esigenze: un adeguato apporto di carboidrati complessi per sostenere le corse, i movimenti continui e la resistenza durante le partite o i match, e un sufficiente apporto proteico per favorire il recupero muscolare dai contatti fisici e dagli sforzi esplosivi ripetuti. Per esempio, un calciatore professionista in stagione agonistica potrebbe assumere circa 6-7 g/kg di carboidrati nei giorni di allenamento intenso (soprattutto sotto forma di pasta, riso, frutta e pane integrale) insieme a ~1,6 g/kg di proteine, completando la dieta con grassi sani (olive, olio d’oliva, frutta secca) per raggiungere l’elevato fabbisogno calorico totale (Bangsbo et al., 2006). Durante il campionato (in-season), quando le partite sono ravvicinate, la priorità nutrizionale è il recupero: pasti ricchi di carboidrati e proteine entro poche ore dal termine di una gara, idratazione attenta e magari snack di recupero come frullati o barrette specifiche subito dopo lo sforzo. Nei periodi di pre-season, invece, per gli sport di squadra c’è un carico di allenamenti fisici e aerobici volto a migliorare la condizione: l’alimentazione in questa fase deve sostenere l’aumento del carico (spesso con due sessioni al giorno) quindi l’atleta curerà molto il timing dei pasti per avere sempre energie disponibili e potrà aumentare leggermente le porzioni. In off-season, molti atleti di sport misti utilizzano il tempo lontano dalle competizioni per recuperare da acciacchi e rilassarsi mentalmente: l’alimentazione in questo periodo sarà più libera ma comunque razionale, mantenendo un occhio al bilancio energetico per non prendere chili di troppo che poi sarebbe difficile perdere alla ripresa degli allenamenti. È magari questa l’occasione per dedicarsi a educazione alimentare, provare nuove ricette sane e consolidare abitudini alimentari positive senza la pressione della gara.
Attraverso questi esempi pratici è evidente come un piano nutrizionale ben congegnato si adatti dinamicamente alle esigenze dell’atleta: la dieta diventa flessibile strumento al servizio della performance e della salute, modulata in base a periodi di carico o scarico di lavoro. Ciò richiede consapevolezza e spesso il supporto di un nutrizionista esperto in ambito sportivo, che possa personalizzare le indicazioni generali al caso individuale, tenendo conto anche delle preferenze alimentari, intolleranze o altri fattori personali.
Integrazioni alimentari: quando servono e quali scegliere
La maggior parte delle esigenze nutrizionali di uno sportivo possono e dovrebbero essere soddisfatte tramite una dieta varia e bilanciata. Tuttavia, in alcuni casi specifici, l’uso mirato di integratori alimentari può risultare utile per migliorare la performance, aumentare la capacità di allenamento o colmare eventuali carenze. È importante sottolineare che qualsiasi integrazione va considerata con un approccio scientifico e preferibilmente sotto la guida di professionisti della nutrizione e medici sportivi, poiché non esistono pozioni magiche: gli integratori funzionano solo se utilizzati correttamente, in un contesto di alimentazione già equilibrata, e le evidenze scientifiche a supporto variano da caso a caso (Maughan et al., 2018). Di seguito analizziamo alcune integrazioni comuni – creatina, beta-alanina, omega-3 e probiotici – evidenziando il perché e il quando potrebbero essere indicate, sempre alla luce dei risultati di studi recenti.
La creatina è forse l’integratore ergogenico più studiato e con maggiori prove di efficacia nel migliorare la performance in sport di potenza e sforzi brevi ad alta intensità. La creatina è una sostanza naturalmente presente nei muscoli (sotto forma di fosfocreatina) che funge da riserva di energia immediata per risintetizzare ATP durante i primi secondi di uno sforzo intenso. Integrare con creatina monoidrato (tipicamente 3-5 grammi al giorno) ha dimostrato di aumentare i livelli intramuscolari di fosfocreatina e conseguentemente migliorare la capacità di sostenere scatti ripetuti, serie di sollevamenti pesi con brevi recuperi e, a lungo termine, favorire maggiori guadagni di forza e massa muscolare (Kreider et al., 2017). Ad esempio, un velocista o un giocatore di calcio potrebbero trarre beneficio in termini di sprint ripetuti più efficaci, oppure un sollevatore di pesi potrebbe riuscire a compiere una ripetizione aggiuntiva grazie alle riserve energetiche potenziate. La creatina ha anche mostrato effetti positivi sulla resintesi di glicogeno post-allenamento e potrebbe contribuire leggermente alla resistenza in sport di squadra, sebbene sia meno rilevante per prestazioni di endurance pura (Dalbo et al., 2018). Va notato che l’assunzione di creatina causa un aumento del contenuto d’acqua intracellulare nel muscolo, e quindi un possibile incremento di peso di 1-2%: questo aspetto va considerato se l’aumento di peso costituisce un limite (ad esempio in sport con categorie di peso). Sul profilo di sicurezza, gli studi non hanno riscontrato effetti avversi significativi della creatina in individui sani, se assunta nelle dosi consigliate (poiché l’eccesso viene escreto tramite i reni), ma è sempre prudente rispettare i dosaggi e scegliere prodotti certificati.
La beta-alanina è un altro integratore che ha guadagnato popolarità, in particolare tra atleti che praticano sport di alta intensità con sforzi protratti nell’ordine di 1-4 minuti (come i 400-800 metri nell’atletica, il canottaggio o circuiti di CrossFit). La beta-alanina è un aminoacido che, assunto regolarmente (in genere 4-6 grammi al giorno in dosi frazionate), eleva i livelli di carnosina intramuscolare. La carnosina agisce come tampone contro l’acidità che si genera nei muscoli durante l’esercizio anaerobico lattacido: in pratica, ritarda l’accumulo di ioni H+ responsabili del calo di pH e del bruciore muscolare, consentendo di prolungare lo sforzo ad alta intensità prima di incorrere nella fatica (Saunders et al., 2017). Studi hanno evidenziato che supplementare beta-alanina per 8-12 settimane può migliorare modestamente la capacità di esercizio ad alta intensità e aumentare la quantità di lavoro totale eseguibile in prove da 60 a 240 secondi (Hobson et al., 2012). Per un nuotatore sui 100 metri o un ciclista su pista, ciò potrebbe tradursi in qualche secondo guadagnato, differenza importante in ambito competitivo. Gli effetti sull’endurance di lunga durata sono invece minimi o nulli, quindi la beta-alanina non è prioritaria per maratoneti o ultratrail runner. Un effetto collaterale innocuo ma comune della beta-alanina è il parestesismo (formicolio) a viso e mani quando assunta in singole dosi elevate; per evitarlo, si consiglia di dividerla in piccole dosi da 1-2 g durante la giornata.
Gli acidi grassi omega-3, solitamente assunti sotto forma di olio di pesce (ricco in EPA e DHA), non sono integratori “ergogenici” nel senso classico, ma rivestono un ruolo prezioso per la salute e il recupero dell’atleta. Questi grassi polinsaturi hanno proprietà antinfiammatorie: competono con gli omega-6 nei processi infiammatori e portano alla produzione di molecole (resolvine, protectine) che favoriscono la risoluzione dell’infiammazione. Nell’ambito sportivo, l’integrazione di omega-3 è stata associata a una riduzione dell’indolenzimento muscolare tardivo (DOMS) dopo esercizi intensi, migliorando il recupero soggettivo (Black et al., 2018). Ad esempio, un allenamento eccentrico molto duro (come una discesa prolungata in montagna o una sessione di squat pesanti) provoca microdanni muscolari e infiammazione locale: alcuni studi hanno trovato che atleti che assumevano omega-3 quotidianamente da diverse settimane presentavano markers infiammatori leggermente inferiori e un recupero della forza più rapido a 48 ore dal esercizio rispetto a chi non li assumeva (Visconti et al., 2021). Inoltre, gli omega-3 contribuiscono alla salute cardiovascolare (importante per sport di endurance) e possono avere benefici cognitivi e sull’umore, utili in fasi di stress psicofisico intenso. La dose efficace varia, ma in genere si consigliano circa 1-2 g al giorno di EPA+DHA combinati per ottenere effetti significativi. È bene sottolineare che l’omega-3 può essere considerato più un nutraceutico per la salute dell’atleta che un supplemento mirato alla performance istantanea: i suoi benefici emergono con l’uso costante nel tempo e riguardano soprattutto la resilienza fisica e la prevenzione degli infortuni e delle malattie.
I probiotici sono integratori costituiti da ceppi di batteri “buoni” che, una volta ingeriti in quantità adeguate, possono colonizzare temporaneamente l’intestino e contribuire all’equilibrio della flora intestinale (microbiota). Negli ultimi anni, l’interesse verso i probiotici in ambito sportivo è cresciuto, poiché si è scoperto che il microbiota intestinale gioca un ruolo significativo non solo nella digestione, ma anche nel modulare l’infiammazione, l’assorbimento dei nutrienti e persino alcuni aspetti dell’immunità e della performance (Jäger et al., 2019). Gli atleti sottoposti a stress intensi, viaggi internazionali, diete particolari o tagli calorici, possono andare incontro a disbiosi intestinali o comunque a disturbi gastrointestinali più frequenti (ad esempio, molti maratoneti lamentano problemi intestinali durante le gare lunghe). L’utilizzo di specifici ceppi probiotici – quali Lactobacillus e Bifidobacterium – è stato associato a una riduzione dell’incidenza di disturbi gastrointestinali e infezioni delle vie respiratorie superiori in atleti endurance in periodo competitivo (West et al., 2019). In altri termini, un integratore probiotico mirato potrebbe aiutare un triatleta a ridurre il rischio di diarrea del viaggiatore quando gareggia all’estero, o un nuotatore a limitare i malanni di stagione durante i periodi di allenamento intenso che sollecitano il sistema immunitario. È fondamentale scegliere probiotici la cui efficacia sia supportata da studi (non tutti i ceppi batterici hanno gli stessi effetti) e assumerli con costanza per alcune settimane per ottenere un beneficio. Come sempre, i probiotici non sostituiscono un’alimentazione ricca di fibre prebiotiche (frutta, verdura, cereali integrali) necessaria a nutrire il microbiota già presente; vanno visti come un aiuto aggiuntivo in situazioni selezionate.
In conclusione, gli integratori come creatina e beta-alanina sono indicati in modo specifico per migliorare determinati aspetti della performance in alcuni sport, mentre omega-3 e probiotici offrono supporto più generale alla salute e al recupero dell’atleta. Prima di iniziare qualsiasi integrazione è consigliato valutare con un professionista la reale necessità e l’appropriatezza, considerando anche possibili interazioni, doping (alcuni integratori contaminati possono causare positività ai controlli antidoping) e la qualità del prodotto. Un approccio scientifico e personalizzato, in linea con la filosofia di Psymed di benessere integrato, garantisce che l’integrazione sia sicura ed efficace.
L'importanza dell'alimentazione nello sport
L’alimentazione dello sportivo rappresenta un affascinante equilibrio tra scienza e personalizzazione: da un lato conosciamo, grazie a numerose ricerche, i principi generali su come macronutrienti e micronutrienti influenzino energia, performance e processi di recupero; dall’altro, ogni individuo è unico per genetica, stile di vita, sport praticato e obiettivi. In questo articolo abbiamo visto come una dieta ben bilanciata in carboidrati, proteine e grassi fornisca il carburante necessario al movimento e i mattoni per la rigenerazione, mentre vitamine, minerali e idratazione ottimale sostengono il delicato motore biochimico che sta alla base della performance fisica. Abbiamo sottolineato l’importanza del timing nutrizionale – alimentarsi nei momenti giusti prima, durante e dopo l’esercizio – per massimizzare l’energia disponibile, migliorare la performance in gara e accelerare i processi di recupero, riducendo anche il rischio di infortuni. È emerso chiaramente come alimentazione e attività fisica siano due facce della stessa medaglia per costruire la salute nello sport e nella vita: insieme fortificano il sistema immunitario, migliorano la composizione corporea, favoriscono il benessere mentale e contribuiscono a una maggiore longevità attiva.
Un altro concetto chiave è l’adattamento della dieta alle esigenze specifiche: abbiamo esplorato esempi di come il piano nutrizionale possa (e debba) cambiare tra un maratoneta, un pesista e un calciatore, e persino come lo stesso atleta moduli l’alimentazione tra pre-season, periodo competitivo e off-season. Questa flessibilità programmata consente di ottenere il massimo da ogni fase di allenamento e di mantenere al contempo uno stato di salute ottimale, evitando squilibri o carenze. Allo stesso tempo, abbiamo discusso del ruolo degli integratori evidenziando che, sebbene possano offrire benefici mirati (come la creatina per la potenza anaerobica o i probiotici per la salute intestinale), non sono soluzioni universali e devono essere impiegati con cognizione di causa, costruendo su una base di corrette abitudini alimentari.
In definitiva, l’alimentazione dello sportivo è un campo in continua evoluzione, dove nuove ricerche affinano le strategie per migliorare la performance atletica in armonia con il benessere generale. Affidarsi a professionisti qualificati – nutrizionisti sportivi, dietisti, medici dello sport – è la scelta migliore per chi desidera un approccio personalizzato e scientificamente fondato. Ogni atleta, dal amatoriale al semi-professionista, può trarre enorme vantaggio da un piano nutrizionale calibrato sul proprio stile di vita attivo: significa dare al proprio corpo i giusti strumenti per rendere al meglio, recuperare più in fretta e mantenersi sano nel lungo periodo. In un’ottica bio-psico-sociale, cara alla mission di Psymed, energia, performance e salute sono tasselli di un unico mosaico: prendersi cura della propria nutrizione significa quindi investire su tutti questi aspetti insieme, per diventare non solo atleti migliori, ma persone più in salute e resilienti.
Fonti principali:
- Aragon, A. A., & Schoenfeld, B. J. (2013). Nutrient timing revisited: is there a post-exercise anabolic window? Journal of the International Society of Sports Nutrition, 10(1), 5.
- Bangsbo, J., & altri (2006). Nutritional needs of elite soccer players. Journal of Sports Sciences, 24(7), 665-674.
- Burke, L. M., & altri (2011). Carbohydrate loading and exercise performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(7), 1331-1338.
- Burke, L. M., Hawley, J. A., Wong, S. H., & Jeukendrup, A. E. (2018). Carbohydrates for training and competition. Journal of Sports Sciences, 36(sup1), 29-38.
- Burke, L. M., & altri (2019). Nutrition for periodized training. Sports Medicine, 49(2), 187-198.
- Cheuvront, S. N., & Kenefick, R. W. (2017). Dehydration: physiology, assessment, and performance effects. Comprehensive Physiology, 8(2), 585-620.
- Cox, G. R., & altri (2010). Dietary strategies to minimize gastrointestinal disturbances during endurance exercise. Sports Medicine, 40(1), 89-102.
- Firth, J., & altri (2020). The efficacy of nutritional supplements and dietary interventions on mental health outcomes in adults: a systematic review of meta-analyses. World Psychiatry, 19(3), 360-380.
- Helms, E. R., & altri (2014). Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 11(1), 20.
- Hobson, R. M., & altri (2012). Effects of β-alanine supplementation on performance: a meta-analysis. Amino Acids, 43(1), 25-37.
- Ivy, J. L., & altri (2017). Nutrient timing: the means to improved exercise performance, recovery, and training. Sports Science Exchange, 29(181), 1-6.
- Jäger, R., & altri (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14(1), 20.
- Jäger, R., & altri (2019). International Society of Sports Nutrition position stand: probiotics. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 16(1), 62.
- Kreider, R. B., & altri (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14(1), 18.
- Lear, S. A., & altri (2017). The effect of physical activity on mortality and cardiovascular disease in 130\u202f000 people from 17 high-income, middle-income, and low-income countries: the PURE study. The Lancet, 390(10113), 2643-2654.
- Lappe, J. M., & altri (2017). Calcium and vitamin D supplementation decreases stress fractures in female navy recruits. Journal of Bone and Mineral Research, 23(5), 741-749.
- Maughan, R. J., & altri (2018). A systematic review of the effectiveness of dietary supplements for athletic performance. Nutrition, 10(10), 1473.
- Morton, R. W., & altri (2018). Timing of protein intake and muscle hypertrophy: a meta-analysis. Nutrition Reviews, 76(7), 479-508.
- Mountjoy, M., & altri (2018). Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S). British Journal of Sports Medicine, 52(11), 687-697.
- Nieman, D. C., & Wentz, L. M. (2019). The compelling link between physical activity and the body's defense system. Journal of Sport and Health Science, 8(3), 201-217.
- O’Keefe, J. H., & altri (2019). Lifestyle choices fuel cardiovascular health. Progress in Cardiovascular Diseases, 62(6), 484-497.
- Pes, G. M., & altri (2013). Lifestyle and nutrition related to male longevity in Sardinia: an ecological study. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 23(3), 212-219.
- Phillips, S. M., & altri (2016). Dietary protein for athletes: from requirements to optimum adaptation. Journal of Sports Sciences, 34(2), 1-10.
- Saunders, B., & altri (2017). β-alanine supplementation to improve exercise capacity and performance: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 51(8), 658-669.
- Sim, M., & altri (2019). Iron considerations for the athlete: a narrative review. European Journal of Applied Physiology, 119(7), 1463-1478.
- Smith, J. W., & altri (2020). Carbohydrate intake and recovery from endurance exercise: impact on subsequent performance. Nutrients, 12(8), 2527.
- Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 116(3), 501-528.
- Visconti, L. M., & altri (2021). Impact of varying doses of omega-3 supplementation on muscle damage and recovery after eccentric exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 18(1), 130.
- Walsh, N. P. (2019). Nutrition and athlete immune health: new perspectives on an old paradigm. Sports Medicine, 49(Suppl 2), 153-168.
- Warburton, D. E., & Bredin, S. S. (2017). Health benefits of physical activity. Current Opinion in Cardiology, 32(5), 541-556.
- West, N. P., & altri (2019). Probiotic supplementation for respiratory and gastrointestinal illness symptoms in healthy physically active individuals. Clinical Nutrition, 38(5), 2171-2177.
L’importanza della RESILIENZA
Resilienza è una parola che ricorre frequentemente da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19; la ritroviamo anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR o Recovery Plan) stilato dal Governo. Ma cos’è esattamente e perché è diventata così importante in questo periodo?
Il termine resilienza per come ha iniziato ad essere usato in psicologia è in realtà una metafora di un fenomeno misurabile in fisica, ovvero dell’attitudine di un corpo a resistere senza rotture in seguito a sollecitazioni esterne brusche o durature di tipo meccanico. I materiali vengono definiti resilienti se, dopo essere stati sottoposti a schiacciamento o deformazione, ritornano alla loro forma iniziale.
E in ambito psicologico cosa vuol dire essere resilienti?
Significa saper affrontare gli eventi stressanti o traumatici, significa piegarsi piuttosto che spezzarsi se sottoposti a pressione, perseverando e adattandosi nell’affrontare le sfide; vuol dire attingere dalle proprie risorse per riprendersi e crescere dopo una crisi.
La resilienza è, in sintesi, tutto ciò che ci serve per sopravvivere a adattarci alle avversità in un mondo stressante ed estremamente complesso.
E noi? Quanto ci sentiamo resilienti? Cosa significa per noi essere resilienti? Da dove viene la nostra resilienza?
La resilienza non è un tratto stabile e immodificabile della personalità ma è qualcosa che chiunque può apprendere, migliorare e sviluppare.
La resilienza inoltre non è una caratteristica presente per tutta la vita: anche per le persone dotate di qualità resilienti possono esserci dei momenti e delle situazioni troppo pesanti da sopportare. Essere resilienti, infatti, non significa essere individui invulnerabili, inaccessibili alle emozioni o alla sofferenza; significa avere le risorse per riuscire ad affrontare le difficoltà o gli stress senza farsi sopraffare.
Ognuno di noi, con l’aiuto di un esperto, può mettere a punto un proprio piano di costruzione della resilienza per acquisire o sviluppare quelle risorse necessarie ad affrontare e superare le avversità e per riuscire, di conseguenza, a riorganizzare positivamente la propria vita.
Perciò ricordando che ciascuno di noi può sempre imparare e cambiare, proviamo a migliorarci!
Conoscere l’ansia: amica o nemica?
Quante volte durante le nostre giornate ci troviamo affannati e sopraffatti dai tanti impegni e dalle importanti responsabilità!
Ormai nel nostro parlare quotidiano la parola “ansia” è entrata a far parte dei nostri discorsi e scambi con amici, colleghi e familiari.
“Mi viene l’ansia!” – “Che ansia!” – “Questa è proprio una situazione ansiogena!” – “Mi fai venire l’ansia!”…
Ma sappiamo davvero che cos’è l’ansia e a cosa serve nella economia della nostra mente?
Per “Ansia” si intende una sensazione di forte “Paura”, estremamente intensa.
ll termine “ansia” deriva dal latino “angĕre”, che significa “stringere”: fa riferimento ad un’intensa sensazione di tensione psicofisica, di preoccupazione e di inquietudine che “stringe” mente e corpo, come se fosse una “morsa”. Spesso si attiva in relazione ad uno stimolo ritenuto minaccioso e nei cui confronti non ci riteniamo sufficientemente capaci di reagire. L’ansia, però, non è sempre “negativa” e in molte situazioni può avere un importante valore adattivo, può addirittura essere considerata una nostra “amica” che ci aiuta ad affrontare situazioni difficili.
Possiamo quindi distinguere un’ “ANSIA FUNZIONALE E ADATTIVA” ed un’ “ANSIA DISFUNZIONALE”.
L’ “ANSIA FUNZIONALE-ADATTIVA” si manifesta come uno stato di tensione psicologica e fisica che implica un'attivazione generalizzata di tutte le risorse dell'individuo, in funzione di uno stimolo realmente esistente e che si configura come una condizione difficile o nuova da affrontare e gestire. Può essere un esame, una riunione importante, un incontro galante, un viaggio, ecc. L’ansia “funzionale” ci permette, quindi, di attivare le nostre risorse per affrontare una situazione percepita come minacciosa oppure nuova e sconosciuta per noi.
L' “ANSIA DISFUNZIONALE”, invece, limita notevolmente le nostre capacità di adattamento, in quanto disturba notevolmente il nostro funzionamento psichico. Ci proietta in una dimensione di dubbio, incertezza e di blocco. Spesso l’ansia disfunzionale non ha una precisa causa riconoscibile oppure un evento scatenante; può determinare comportamenti di difesa che limitano l'esistenza, come l'evitamento di situazioni ritenute potenzialmente pericolose (es. guidare la macchina; prendere l’aereo; ecc)
Fra i sintomi più comuni dell’ansia disfunzionale abbiamo: senso di paura e di pericolo imminente; paura di perdere il controllo; tensione interna soggettiva; difficoltà a rilassarsi; apprensione; ipervigilanza; inquietudine; irritabilità ed impazienza; difficoltà a concentrarsi e scarsa attenzione.
Anche il nostro corpo ci manda dei segnali importanti quando ci sentiamo sopraffatti dall’ansia disfunzionale: difficoltà di respirazione; respiro corto e accelerato; Vertigini; Sensazione di instabilità e mancato equilibrio; Sensazione di "nodo in gola"; Battito cardiaco accelerato o non regolare; Sudorazione eccessiva; Senso di debolezza e stanchezza; Tensione muscolare; sintomi gastrointestinali.
L'ansia disfunzionale, generalmente, richiede l'intervento dello specialista che saprà diagnosticare quale tipo di disturbo ansioso affligge la persona e quale trattamento meglio si addice al singolo caso.
Presso lo studio multi professionale PSYMED a Roma è possibile effettuare una valutazione diagnostica delle manifestazioni ansiose e progettare percorsi di PSICOTERAPIA del tutto personalizzati, integrati con pratiche di tipo psicocorporeo (TRAINING AUTOGENO, MINDFULNESS, YOGA) che promuovono il rilassamento ed il benessere generale della persona.
Quando e perché chiedere una consulenza psicologica
Gli utenti di solito fanno richiesta di consulenza psicologica per:
- affrontare situazioni problematiche che non sanno come gestire e che riguardano diversi ambiti (personale, familiare, evolutivo, pedagogico, professionale, ecc.). Le difficoltà, i dubbi, la crisi, le frustrazioni e le preoccupazioni creano disagio e le persone sentono che le proprie capacità di agire e di pensare in modo efficace sono bloccate o compromesse.
- Riappropriarsi di opportunità perdute e potenzialità non usate. Oltre a situazioni problematiche le persone sono spesso in difficoltà perché non usano le opportunità o non sfruttano le potenzialità a loro disposizione.
In generale, chi si rivolge allo psicologo per una consulenza psicologica (sia esso individuo, coppia o organizzazione) “avverte, anche se spesso in maniera confusa ed imprecisa, una sorta di discontinuità tra la propria capacità di agire per il raggiungimento di un obiettivo e tale obiettivo, ovvero lo scopo verso il quale l’azione è diretta” (M. Grasso, S. Salvatore, 1993).
Lo scopo della consulenza psicologica è quello di sostenere, motivare, abilitare o riabilitare la persona all’interno della propria rete affettiva, relazionale e valoriale, al fine anche di esplorare difficoltà relative a processi evolutivi o involutivi, fasi di transizione e stati di crisi anche legati a cicli di vita, rinforzando capacità di scelte, di problem solving o di cambiamento (CNOP, Atti Tipici e Riservati della Professione Psicologica: la Competenza del Counseling 20/06/2020).
La relazione di consulenza è collaborativa. L’utente impara ad aiutare se stesso e l’operatore ha la funzione di “facilitatore” dei processi perché accompagna e facilita l’utente nel raggiungimento dei propri risultati.
L’intervento del professionista sarà efficace, infatti, nella misura in cui gli utenti, dopo l’interazione con lui, sono in grado di gestire le situazioni problematiche o sanno come usufruire di risorse fino allora non usate o sono in grado di usare opportunità per vivere in modo efficace e funzionale.
Consulenza e Sostegno psicologico
I vantaggi per l’utente che effettua un percorso di consulenza “efficace” sono:
- essere accolto, ascoltato e supportato all’interno di uno spazio di relazione;
- riflettere e condividere tematiche personali ed emotivamente rilevanti;
- confrontarsi con i propri sentimenti e conflitti interiori;
- essere aiutato nella definizione e valutazione del problema e delle sue implicazioni nel più ampio contesto di vita personale e di relazione (esplora e chiarisce);
- scoprire prospettive diverse che consentono di attribuire un nuovo senso e significato al problema;
- fare ordine e chiarezza su ciò che vuole, stabilendo priorità e obiettivi concreti e realistici;
- essere supportato nell’individuazione di strategie di azione adatte al raggiungimento dei propri obiettivi;
- scoprire modalità di comportamento più funzionali e correttivi efficaci per il cambiamento;
- superare l’immobilismo decisionale;
- acquisire un senso di valore personale e di benessere quando raggiunge il proprio obiettivo di migliorare e acquisire competenza e abilità nell’affrontare i problemi;
- avere l’opportunità di conoscere, crescere e cambiare partendo da una situazione negativa e di crisi;
- migliorare la qualità della propria vita personale, di relazione e sociale.
La consulenza richiede un numero definito di incontri e può evolvere, se necessario, in un percorso di sostegno psicologico o di psicoterapia.
Se desideri maggiori informazioni contatta la Dott.ssa Maria Cristina - Psicologa a Roma
Dott.ssa Eleonora Ottaviani - Psicologa a Roma

Dott.ssa Eleonora Ottaviani - Psicologa
Sono una psicologa clinica, mi chiamo Eleonora Ottaviani e offro percorsi di sostegno psicologico individuale e di coppia ispirati all’approccio umanistico-esistenziale. Credo profondamente nella possibilità di ogni persona di ritrovare equilibrio, significato e autenticità, anche nei momenti più complessi della propria vita. Il mio lavoro si fonda sull’ascolto empatico, sulla presenza autentica e sulla costruzione di una relazione di fiducia, in cui sentirsi accolti e liberi di esplorare il proprio mondo interiore.
Mi sono laureata in Psicologia Clinica e della Riabilitazione e ho completato una formazione triennale post-laurea in consulenza psicologica affettivo-relazionale centrata sulla persona. Sono iscritta all’Albo A degli Psicologi del Lazio. Integro nella mia pratica strumenti che favoriscono la consapevolezza, la gestione delle emozioni e la valorizzazione delle risorse personali, con particolare attenzione alla dimensione relazionale ed esistenziale.
In particolare offro supporto psicologico in caso di ansia, attacchi di panico, stress, depressione, difficoltà relazionali, dipendenze affettive, identità di genere, orientamento sessuale, crisi esistenziali, senso di vuoto e crescita personale. Lavoro con giovani adulti, adulti e coppie, offrendo uno spazio sicuro e non giudicante in cui poter riflettere, esprimersi e intraprendere un percorso di consapevolezza e crescita .
Parallelamente alla mia attività clinica, mi occupo di formazione aziendale su tematiche legate al benessere organizzativo, alla leadership e all’orientamento professionale, ed offro consulenze cliniche per una multinazionale svizzera che si occupa di benessere aziendale. Ho inoltre ideato e condotto laboratori di scrittura autobiografica come strumento di esplorazione personale e narrazione del sé. Ricevo in presenza a Roma (qui a Trastevere o in zona Axa, Acilia) e ad Ardea (Tor San Lorenzo), e offro anche consulenze online.
Per contattare la Dott.ssa Eleonora Ottaviani
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La terapia familiare: “siamo una famiglia normale”?
Che cosa è una famiglia normale?
Quando una persona chiede un aiuto psicologico per qualcuno della famiglia che sta attraversando un momento di difficoltà e di disagio teme sempre un giudizio negativo sul suo operato.
Parlare di un figlio, di un fratello o di un partner che ha problemi di ansia, depressione o dipendenza porta con sé il timore di aver sbagliato qualcosa, il peso di sentirsi responsabili per qualcosa che non va nelle proprie relazioni familiari. Purtroppo il senso comune ed il pregiudizio portano molte persone a pensare che se qualcuno mostra un sintomo, un disagio o un malessere bisogna cercare un “colpevole”. Spesso le persone che chiedono aiuto hanno bisogno di sottolineare che provengono da una “famiglia normale” e che hanno tentato di dare il meglio ai loro cari.
La complessità del disagio mentale e delle relazioni familiari non possono ridursi a questa visione così semplicistica e per nulla realistica: la sofferenza non ha colpevoli. Ogni membro della famiglia soffre a suo modo ed ha diritto di essere accolto e ascoltato.
Come si realizza il percorso di sostegno e la terapia familiare?
In un percorso di “TERAPIA FAMILIARE” la prese in carico della famiglia prevede il coinvolgimento di tutti i membri, allo scopo di ascoltare e accogliere la sofferenza di ognuno e di individuare e rinforzare le risorse e le capacità di autoguarigione che ogni famiglia porta con sé. Il coinvolgimento della famiglia nel percorso di cura ha una potente funzione terapeutica, finalizzata al rinforzo dell’appartenenza di gruppo, alla gestione bilanciata di regole e ruoli, al miglioramento della comunicazione e dei livelli di soddisfazione personale e relazionale.
La terapia familiare è particolarmente indicata per affrontare problematiche connesse al ciclo vitale e all’età evolutiva (bambini, adolescenti, giovani adulti); per la gestione di eventi stressanti e/o traumatici (trasferimenti, separazioni, perdite, lutti, PTSD, ecc); per condizioni cliniche specifiche (disturbi del comportamento alimentare, tossicodipendenze, psicosi, depressioni, ecc).
Presso lo studio multiprofessionale PSYMED a Roma è possibile effettuare percorsi di TERAPIA FAMILIARE in presenza o in remoto, per valutare e gestire eventuali disagi emotivi e relazionali, potenziare le capacità comunicative e di risoluzione dei problemi, gestire i conflitti e rinforzare le risorse all’interno della propria famiglia.
Le “bolle di respiro”: sopravvivere alla “psico-pandemia”
Dott.ssa Claudia Agostino – Psicologa Psicoterapeuta
L’emergenza sanitaria da COVID-19 che stiamo vivendo ci costringe a vivere in un tempo sospeso, immobile, dove tutto sembra fermo, ma allo stesso tempo siamo chiamati a muoverci e a continuare a vivere le nostre giornate, adempiendo ai nostri compiti e alle nostre responsabilità. Spesso ci risulta difficile organizzare le varie attività, sia a casa che fuori e ci sentiamo sopraffatti da un senso di impotenza e frustrazione.
In un precedente articolo in questo Blog dello Studio Psymed, ho accennato ad alcuni rimedi per affrontare gli effetti di quella che viene chiamata la “Psico-Pandemia”.
Fra questi ho fatto riferimento a quelle che definisco le “BOLLE DI RESPIRO”, ovvero momenti circoscritti e definiti all’interno della nostra giornata in cui recuperiamo forza ed energia.
Scegliamo un momento della giornata in cui sappiamo che possiamo ritagliarci del tempo: può essere la mattina appena svegli, o in pausa pranzo, oppure la sera prima di addormentarci.
REGALIAMOCI UNA “BOLLA DI RESPIRO” ?
- Scegliamo un momento della giornata in cui ritagliarci del tempo, anche minimo, come 5 o 10 minuti
- Può essere la mattina appena svegli; in una pausa pranzo oppure la sera prima di andare a letto
- possiamo decidere di svolgere un'attività che ci rilassa o ci permette di ricaricare le batterie
- può essere una respirazione consapevole, una pratica di mindfulness, un esercizio di training autogeno, un po’ di yoga, l'ascolto di una musica rilassante, un bagno caldo o una doccia ristoratrice, fatta in consapevolezza
Ognuno sceglie la sua pratica da effettuare nella propria “bolla di respiro”; l'importante è che sia effettuata in piena consapevolezza.
Presso lo studio multiprofessionale PSYMED a Roma è possibile effettuare colloqui in presenza o in remoto, per valutare e gestire eventuali disagi emotivi e relazionali e progettare percorsi di promozione alla salute e di gestione dello stress attraverso il training autogeno la mindfulness e lo yoga.
Proteggersi dalla “psico-pandemia”
Dott.ssa Claudia Agostino – Psicologa Psicoterapeuta
Dopo un anno dalla dichiarata pandemia da Covid-19 da parte dell’OMS, le misure di sicurezza dettate dalle nuove zone rosse ci proiettano in un tempo immobile, come se nulla fosse cambiato: attività commerciali, sportive e culturali fortemente limitate o sospese; scuole chiuse e tutte in DAD.
Abbiamo la sensazione che tutti gli sforzi, tutti i sacrifici e tutte le rinunce che abbiamo fatto da un anno a questa parte, non abbiano avuto alcun effetto, se non quello di accumulare frustrazione e sfiducia.
Quello che stiamo vivendo è un momento molto delicato: la stanchezza e le difficoltà economiche e sociali stanno appesantendo le vite familiari e corrodendo le relazioni; l’isolamento sociale sta amplificando malesseri pregressi e generandone di nuovi. Il disagio emotivo sta dilagando alla stessa velocità del virus, ma con minore possibilità di essere intercettato. Qualcuno parla di “Psico-pandemia” per descrivere questo effetto secondario correlato alla pandemia da COVID-19; sembra una sorta di “onda d’urto” oppure uno tsunami che devasta le terre, in seguito al maremoto.
Non esistono “tamponi emotivi” per il panico, le depressioni, le reazioni aggressive, l’abuso di alcol e droghe! Né tantomeno vaccini per proteggerci dal disagio e dalla paura per il futuro.
E allora cosa possiamo fare per non lasciarci andare alla confusione, al malessere e al pessimismo?
COME PROTEGGERCI DALLA “PSICO-PANDEMIA” ?
- Rimanere focalizzati nel presente, senza andare troppo avanti nel tempo, con visioni funeste del futuro
- Evitare il sovraccarico di informazioni cercando sui social, sul web e sui mass media
- Evitare la ricerca ossessiva e ridondante di informazioni sui contagi, i ricoveri, le vittime
- Seguire le linee guida delle istituzioni ufficiali e del Ministero della Sanità
- Scandire le giornate con abitudini pressoché costanti, senza lasciarsi andare alla passività
- Cercare di rimanere “connessi” con le persone a noi care, sfruttando in modo costruttivo i mezzi di comunicazione
- Muovere il corpo: passeggiare e fare attività fisica all’aria aperta, nel rispetto delle misure di sicurezza oppure svolgere semplici esercizi in casa
- Ritagliarsi ogni giorno piccoli “rituali di benessere” o “bolle di respiro” per ricaricarci di sensazioni positive
- Se ci rendiamo conto che non riusciamo a superare un momento di forte malessere, di panico o di depressione, chiediamo aiuto al nostro medico di riferimento e ad uno psicologo-psicoterapeuta di fiducia.
Presso lo studio multi professionale PSYMED è possibile effettuare colloqui in presenza o in remoto, per valutare e gestire eventuali disagi emotivi e relazionali.